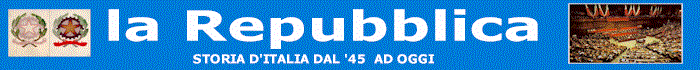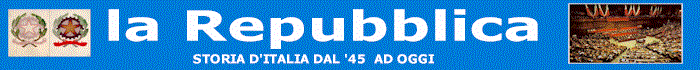|
Bibliografia
sulla storia della Repubblica italiana
a cura di Mario Avagliano
AA.VV., L’Italia dalla
liberazione alla repubblica (Atti del Convegno internazionale, Firenze, 26-28 marzo 1976),
collana Insmli, Milano, Feltrinelli, sd.
AA.VV., Storia
dell’Italia repubblicana, Torino, Einaudi, 1994-1997
Giorgio Bocca, Storia della Repubblica Italiana, Rizzoli
Editore, Milano 1981
Giampiero Carocci, Storia dell’Italia dall’unità
a oggi, Milano, Feltrinelli, 1975
Valerio Castronovo e altri, L’Italia
contemporanea 1945-1975, Torino, Einaudi, 1976
Camillo Daneo, La politica economica della ricostruzione 1945-1949,
Torino, Einaudi, 1975
Marcello Flores e altri, Gli anni
della Costituente. Strategie dei governi e delle classi sociali, Milano, Feltrinelli,
1983
Antonio Gambino, Storia del
dopoguerra. Dalla liberazione al potere Dc, Bari, Laterza, 1975
Paul Ginsborg, L’Italia dal
dopoguerra ad oggi, 2 vol., Torino, Einaudi, 1989
Silvio Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, Venezia,
Marsilio, 1992
Massimo Legnani, Restaurazione padronale e lotta politica in Italia
1945-1948, “Rivista di storia contemporanea”, gennaio 1974
Aurelio Lepre, Prima storia della prima repubblica, Bologna,
Il Mulino, 1994
Aurelio Lepre, Storia della prima Repubblica - L'Italia dal 1945 al
1998, Bologna, Il Mulino, 1999
Denis MacSmith, Storia dell’Italia unita, Bari,
Laterza, 1997
Indro Montanelli e Mario Cervi, L'Italia del Novecento - Un viaggio
lucido e disincantato attraverso il Ventesimo secolo, Ed. RCS Libri, Milano 2000
Enzo Piscitelli e altri,
L’Italia 1945-48. Le origini della repubblica, Torino, Giappichelli, 1974
Pietro Scoppola, La Repubblica dei partiti, Bologna, Il
Mulino, 1990
Stuart Woolf e altri, Italia
1943-1950. La ricostruzione, Bari, Laterza, 1974
Sergio Zavoli, C'era una volta la prima Repubblica - Cinquant'anni
della nostra vita, Arnoldo Mondatori Editore, collezione Oscar, Milano 1999
 Bibliografia del '68 Bibliografia del '68
 Bibliografia
del Movimento del '77 a cura di Sébastien Croquet (Université des
sciences humaines d'Aix en Provence) Bibliografia
del Movimento del '77 a cura di Sébastien Croquet (Université des
sciences humaines d'Aix en Provence)
 Bibliografia del terrorismo Bibliografia del terrorismo
---------------------------
Gli storici e l’Italia
repubblicana
a cura di Nicola Tranfaglia
Il tema è "Gli storici e l’Italia repubblicana", cioè
come gli storici, non solo italiani, hanno affrontato il problema della storia
dell’Italia repubblicana. In fondo, una riflessione che ho avuto modo di fare spesso
parlando con i miei studenti, è che noi parliamo del fascismo come di un’epoca
lunghissima, che ha segnato la storia d’Italia, e poi tendiamo a dedicare meno
attenzione alla storia dell’Italia repubblicana che, in termini di durata, finora è
più del doppio dell’esperienza fascista. Questo succede sempre quando si tratta di
periodi vicini, che ci hanno visto testimoni e a volte persino attori delle cose che sono
successe.
Gli storici hanno sempre bisogno di usare in qualche modo il senno di
poi, e il senno di poi è difficile da usare per descrivere un’esperienza come quella
repubblicana, che è ancora aperta. Si parla moltissimo, per esempio, sui mezzi di
comunicazione di massa di prima e di seconda Repubblica, ma quello che è certo è che
fino a oggi noi apparteniamo a una fase storica che è caratterizzata dalla Costituzione
repubblicana del 1948. Non esiste una nuova Costituzione e, d’altra parte, non è
detto che mutamenti nella Costituzione significhino di per sè una fase completamente
diversa. Quella che stiamo vivendo è perciò un’esperienza ancora aperta e, a mio
avviso, più aperta di quanto si possa intuire.
Prima di tutto ci si deve chiedere perché così tardi gli storici
abbiano proposto agli italiani dei lavori di sintesi approfonditi sull’Italia
repubblicana. Perché così tardi si è incominciato a offrire delle interpretazioni,
seppure su una parte non ancora conclusa della storia dell’Italia repubblicana. Le
ragioni sono varie. Prima di tutto, a mio avviso, c’è stata a lungo fra gli storici
una mancanza di consapevolezza critica, che è durata fino alla fine degli anni Settanta e
i primi anni Ottanta, sull’influenza decisiva per la storia dell’Italia
repubblicana esercitata da quello che un gruppo di storici, che ha ideato e in gran parte
scritto la "Storia dell’Italia repubblicana" pubblicata da Einaudi, ha
definito come il rapporto tra nazionale e internazionale. C’è stata una mancata
consapevolezza critica del fatto che la storia dell’Italia repubblicana, almeno fino
a pochi anni fa, è stata potentemente influenzata da questo rapporto: ciò significa
considerare il peso della guerra fredda in Italia, la divisione del mondo in due blocchi,
la sovranità limitata di cui ha potuto godere l’Italia, un paese che è stato un
avamposto di frontiera del blocco filo americano, cioè di una delle due parti. Nello
stesso tempo l’Italia è stata la sede del Partito comunista più forte
dell’Europa occidentale. In questa compresenza di tali fattori c’è una delle
ragioni della difficoltà di interpretazione e di mancata consapevolezza critica.
Un secondo elemento è l’accumularsi di una quantità imponente di
misteri e di zone oscure (la mafia, le società segrete, la P2, le stragi, i terrorismi,
il cosiddetto "governo invisibile", come l’ha definito Norberto Bobbio, che
è sempre stato attento a quello visibile).
Poi ci sono stati motivi che sono interni alla stessa disciplina
"storia contemporanea", che hanno influito su questo ritardo: innanzi tutto,
metterei l’arretratezza della nostra Università, che fino alla metà degli anni
Settanta ha ospitato esclusivamente cattedre di Storia del Risorgimento, un Risorgimento
infinito, che durava praticamente dagli anni Quaranta e Cinquanta dell’Ottocento,
fino alla seconda guerra mondiale. Non a caso, quando uscì una delle prime opere
collettive sulla Resistenza, fu intitolata appunto "Il secondo Risorgimento".
Non si riusciva a uscire dall’ottica di un Risorgimento che si espandeva sempre di
più: l’età contemporanea non esisteva. Il primo concorso di storia contemporanea è
del 1972 e assegna soltanto tre posti; bisogna aspettare quattro anni perché comincino a
espandersi in Italia gli insegnamenti di storia contemporanea.
Un altro elemento credo che sia stato la scarsa apertura dei
contemporaneisti italiani alla storia economica e sociale. Non è un caso che le prime
opere dedicate all’Italia repubblicana, quelle di Norman Kogan e di Giuseppe
Mammarella uscite tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, non furono altro che cronache
ragionate della vita politica e parlamentare italiana: entrambe non uscivano, come avrebbe
detto Pasolini, dal Palazzo, e raccontavano che cosa si faceva all’interno dei
partiti e del Parlamento. Intendiamoci, i partiti erano molto importanti in quegli anni;
però il fatto di non mettere il naso fuori, di usare esclusivamente le fonti ufficiali,
di non parlare della vita sociale italiana, contribuisce a dare vita a un’immagine
deformata. Entrambi gli autori, nettamente anticomunisti, davano del Pci un’immagine
che corrispondeva alla vita dei gruppi dirigenti e non a quello che il Pci era a livello
di società: non consideravano le cooperative, le associazioni, i modelli di vita, di
cultura e di famiglia che erano propri della sinistra comunista in Italia. Quindi
l’immagine che davano era deformata e, lo stesso avveniva per il maggior partito di
governo : la Dc. Si parlava solo dei capi democristiani, del rapporto tra i gruppi
dirigenti e la Chiesa, che certo era molto importante, ma non esauriva la capacità di
consenso che la Dc aveva attraverso un’organizzazione capillare, in parte
ecclesiastica, in parte laica, nella società italiana.
Negli anni Settanta, si trovano inoltre delle sintesi interessanti
sulla storia repubblicana in volumi che si ponevano però il problema di ricostruire
l’intera storia dell’Italia unita. In particolare, si tratta della Storia
dell’Italia unita di Denis MacSmith, pubblicata da Laterza, di cui proprio in
questi giorni è uscita l’edizione che porta il racconto fino al 1997, e della Storia
dell’Italia dall’unità a oggi di Giampiero Carocci, pubblicata da
Feltrinelli. In entrambe c’erano delle pagine interessanti, nel senso che proponevano
un’interpretazione: la prima era un’interpretazione che chiamerei democratico -
radicale, la seconda la definirei comunista - riformista. Per esempio, nell’opera di
Carocci, che ebbe un grande successo a metà degli anni Settanta, è molto significativo
il confronto che l’autore fa tra Giolitti e Moro. Carocci sostiene che Moro è una
sorta di Giolitti nuovo, un Giolitti che media tra le forze politiche, cercando di aprire
alla sinistra, ma mantenendo il potere del centro. In altri termini: riforme sì, ma molto
trasformismo. Con MacSmith e Carocci siamo poi di fronte a due studiosi che sono
specialisti dell’Ottocento e del fascismo e che quindi non vedono una serie di
problemi, soprattutto economici e sociali, che sono nati o che hanno avuto una particolare
accelerazione dopo il 1945. Questo è un loro difetto.
Fino alla metà degli anni Ottanta, ci si trova di fronte a studi
parziali, che illuminano aspetti significativi della storia dell’Italia repubblicana,
che diventeranno in qualche caso dei classici, ma che non superano la prima parte del
periodo considerato. Vorrei citare inoltre, tra i tanti, la Storia del dopoguerra dalla
Liberazione al potere Dc di Antonio Gambino, che analizza in maniera molto
significativa e ben documentata il triennio che segue la Liberazione, dal ‘45 al
‘48; è questo il periodo che detta le coordinate dell’affermazione della Dc
come partito centrale di governo, fatto che resterà significativo fino alla metà degli
anni Settanta, quando si apre la grande crisi politica dell’Italia repubblicana.
Solo a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta si hanno delle
sintesi della storia dell’Italia repubblicana che prendono atto sia di quel rapporto
nazionale/internazionale di cui si diceva, sia della necessità di innovare rispetto alla
storiografia precedente e di porre come perno del discorso la lunga esperienza della
"democrazia dei partiti", come dirà Pietro Scoppola, che ha costituito il
centro dell’Italia repubblicana.
Prima di parlare di queste opere, è utile accennare alla
periodizzazione che mano a mano si è affermata tra gli storici: mentre nelle opere
scritte negli anni Sessanta e Settanta, la periodizzazione era molto incerta e a volte
indicava con la fine degli anni Settanta il termine dell’esperienza repubblicana, con
la storiografia successiva si hanno delle periodizzazioni che diventano sempre più
simili, pur nella differenza delle interpretazioni. Oggi, la maggior parte degli storici
concorda su un primo periodo che si può definire di ricostruzione e di costruzione
della democrazia repubblicana, che va dalla fine della seconda guerra mondiale alla
metà degli anni Cinquanta (è il periodo in cui si delinea la realizzazione di buona
parte del dettato della Costituzione repubblicana, che per i primi anni, come dicono i
giuristi, era stata congelata, non attuata: è del 1956 l’inizio di attività della
Corte Costituzionale, mentre è del 1958 l’inizio dell’attività del Csm. Dal
punto di vista economico e produttivo si pongono le basi del futuro "boom"
economico e si ricostruisce sulle rovine della seconda guerra mondiale); il secondo
periodo si può definire come gli anni del miracolo economico (1958-1964) e del
centrosinistra (dalla fine degli anni Cinquanta al Sessantotto); un terzo periodo è
quello della contestazione (ribellione studentesca e lotte sociali) e del
compromesso storico (la strategia d’incontro con la Dc, lanciata da Berlinguer
dopo il colpo di stato della Cia e delle destre in Cile, che si realizzerà poi con i
governi di unità nazionale alla metà degli anni Settanta); un quarto periodo, è detto della
crisi della Repubblica (si apre con il fallimento del compromesso storico, prosegue
con i governi di pentapartito e arriva fino al vero crollo del sistema dei partiti nei
primi anni Novanta); un quinto periodo non lo possiamo ancora definire perché è in
corso, e lo si può dire della transizione, ma non sappiamo verso che cosa e quanto
durerà.
Questa periodizzazione emerge dalle opere più significative pubblicate
a partire dalla fine degli anni Ottanta, fino a tutti gli anni Novanta.
La prima che va segnalata è senza dubbio la Storia d’Italia
dal dopoguerra a oggi dell’inglese Paul Ginsborg, pubblicata nel 1988 da Einaudi.
Ginsborg, che ha scelto di vivere e insegnare in Italia, ha studiato a fondo anche la
Venezia di Daniele Manin e la lotta italiana per l’unificazione nazionale della metà
dell’Ottocento. Il libro di Ginsborg precede di pochi mesi il crollo del muro di
Berlino e forse anche per questo ottiene in Italia grande successo.
Se si va ad analizzare le ragioni del successo della sintesi di
Ginsborg (un volume di circa 800 pagine), si nota prima di tutto una scrittura limpida e
piacevole, anglosassone (gli storici italiani scrivono troppo spesso per gli altri storici
e non per i lettori). La seconda ragione è un’attenzione inconsueta, per la
contemporaneistica italiana, per la storia della società e delle masse popolari;
un’altra ragione è l’interpretazione non ideologica che Ginsborg dà del ruolo
decisivo svolto dai partiti storici della sinistra, e dal Pci in particolare,
nell’affermazione della democrazia italiana, pur senza omettere gli aspetti positivi
dei governi centristi e di centrosinistra negli anni Cinquanta e Sessanta. Il libro di
Ginsborg ha questo equilibrio storiografico, a mio avviso molto apprezzabile: da un lato,
non dà dei partiti della sinistra e in particolare del Pci quell’immagine ideologica
che avevano dato Kogan e Mammarella, e intuisce come questi partiti fossero espressione
della società civile e fossero radicati nelle masse popolari; dall’altro, mette in
evidenza gli aspetti positivi dell’opera di governo della Dc e dei partiti laici
minori. Per Ginsborg, negli anni Cinquanta c’è stata sì discriminazione politica
nelle fabbriche e nello Stato contro i militanti della sinistra, ma si dà atto dei meriti
dei partiti di governo per aver guidato il paese nella preparazione del miracolo
economico.
Ginsborg fa scoprire ai lettori, secondo una prospettiva non
trionfalistica, ma di sicuro ottimistica e legata a una difesa netta del paradigma
antifascista, le grandi trasformazioni che hanno condotto l’Italia a diventare, dopo
gli anni Sessanta, una grande potenza industriale, senza mancare di mettere in evidenza
contraddizioni e problemi irrisolti dell’Italia degli anni Settanta e Ottanta.
L’autore insiste a ragione sul ruolo centrale che hanno avuto istituzioni come quella
familiare e come i sindacati dei lavoratori; ricostruisce episodi e vicende del tutto
assenti nelle precedenti sintesi storiche.
Le nuove generazioni, come ho potuto osservare adottandolo nei miei
corsi universitari, trovano nella narrazione punti di riferimento che mancavano sugli anni
Cinquanta, con le loro ombre e le loro luci, sul miracolo economico, sul divario tra nord
e sud, sul grandissimo fenomeno (trascurato in precedenza dagli storici) delle migrazioni
interne, sulle riforme promesse e poi non realizzate negli anni Sessanta, su quelle
riforme decise a livello legislativo, ma poi boicottate dalla burocrazia e da quei blocchi
di potere conservatori e reazionari presenti nella società italiana.
Tra le critiche che possiamo muovere al libro di Ginsborg (non
c’è studio, per quanto riuscito, che non faccia poi nascere delle critiche,
com’è ovvio), c’è da una parte un’attenzione non sempre costante alla
politica (ci sono delle parti del libro in cui si perde un po’ la trama della vita
politica), e dall’altra il fatto che la storia proceda serrata fino agli anni
Settanta, ma poi diventi più vaga e perda un certo mordente quando tratta
dell’ultimo decennio, a proposito dei pur importanti anni Ottanta.
Questa è comunque la prima opera che pone sul terreno
dell’approfondimento e dello sforzo interpretativo la storia dell’Italia
repubblicana.
Due anni dopo, nel 1990, quando il muro di Berlino è crollato e
l’Urss sta per cedere il passo alla disgregazione, uno tra i migliori storici del
filone storico - democratico, Pietro Scoppola, pubblica il frutto delle sue lezioni
universitarie con il titolo La Repubblica dei partiti, presso Il Mulino. Il
sottotitolo dell’opera di Scoppola ne chiarisce il centro e gli obiettivi:
"Profilo storico della democrazia in Italia. 1945 - 1990". L’autore non si
propone, a differenza di Ginsborg, di narrare criticamente l’ultimo cinquantennio,
bensì di offrire un saggio interpretativo sulla parabola della democrazia dei partiti,
che è stata al centro dell’Italia repubblicana. Non si parla ancora di prima e di
seconda Repubblica, come si inizierà a fare a partire dal 1992, ma leggendo le pagine
chiare e in un certo senso didascaliche di Coppola, si ha la netta sensazione di come,
agli inizi degli anni Novanta, stia per avere inizio la disgregazione di quel sistema dei
partiti che ha retto l’Italia nei quasi cinque decenni successivi alla Liberazione.
Scoppola assume come propria la distinzione fra i tre grandi partiti
popolari che hanno costruito la democrazia in Italia, la Dc, il Pci e il Psi, e le altre
forze politiche minoritarie d’élite o anti-sistema, come il Movimento sociale e i
monarchici a destra, o i gruppi extraparlamentari a sinistra. Egli giustifica senza
esitazioni l’esclusione dal governo del Pci, legato all’Urss, fino al
compromesso storico tra Moro e Berlinguer, esalta il ruolo del centrismo degasperiano e
anche la graduale apertura a sinistra promossa prima da parte di Fanfani e poi da Moro e
Zaccagnini; sono notevoli le pagine che Scoppola dedica alla forte eredità del fascismo
nell’Italia repubblicana, essendo il primo a sottolineare questo punto, che altri
storici in precedenza non avevano messo in luce: molte delle contraddizioni
nell’opera di riforma, sia dei centristi, sia del centrosinistra, sono dovute al peso
della dittatura e del fascismo.
Anche notevoli sono le pagine sull’edificazione e
sull’attuazione conflittuale della Costituzione, sulle contraddizioni dello sviluppo
capitalistico negli anni Settanta e Ottanta. Egli nota, per esempio, che la Dc ha guidato
lo sviluppo economico pur non avendo una propria teoria economica e che a tal fine ha
utilizzato gli economisti liberali e liberisti; questo spiega il fatto che poi, negli anni
Settanta, la Chiesa cattolica, prima così legata alla Dc, critichi a fondo il modello
economico costruito nei decenni precedenti. Non si tratta infatti di un modello né
cattolico, né solidaristico, bensì liberale e liberista. C’è una ragione che
spiega questo fatto: gli economisti cattolici solidaristi erano stati tutti fascisti, a
cominciare da Fanfani e De Maria, per cui erano impresentabili nell’immediato
dopoguerra. La Dc è stata così obbligata ad appoggiarsi agli economisti liberali
antifascisti o per lo meno non fascisti.
Scoppola dedica delle pagine molto interessanti sul particolare welfare
creato in Italia dai governi centristi e di centrosinistra. E, infine, critica a ragione
la politica del pentapartito repubblicano e socialista negli anni Ottanta.
Naturalmente non ci troviamo di fronte a una vera storia
dell’Italia repubblicana, come si era visto con il libro di Paul Ginsborg, ma di
fronte a un libro utile a comprendere gli aspetti politico - culturali della vicenda
italiana, e a un punto di vista importante per il filone di pensiero che rappresenta, il
cattolicesimo democratico nell’Italia contemporanea.
L’anno ancora successivo, nel 1991, la storiografia italiana
registra l’uscita di un’opera che si colloca accanto a quella di Paul Ginsborg,
tra quelle che possiamo ora definire fondamentali sull’ultimo cinquantennio. E’
la Storia dell’Italia repubblicana scritta da Silvio Lanaro e pubblicata da
Marsilio. Lanaro è uno storico attento alla storia sociale e culturale, ma anche a quella
politica e religiosa, è uno storico veneto che ha studiato l’influenza della Chiesa
cattolica nella sua regione, che è stata a lungo la regione bianca per eccellenza.
Anche l’opera di Lanaro ha un successo notevole, sia nelle
librerie, sia nelle Università; come Ginsborg coniuga narrazione e giudizio critico e
come lo storico inglese dà grande spazio alla grande trasformazione sociale, economica e
culturale degli anni Cinquanta, proponendo un giudizio molto più duro sul Sessantotto e
sulle lotte sociali degli anni Settanta, e difendendo al contrario il decennio socialista
degli anni Ottanta, il che, francamente, sul piano storiografico, è più discutibile.
Quando ci si è allontanati dal decennio craxiano si sono infatti visti meglio quegli
aspetti negativi che, quando Lanaro ha scritto, erano forse meno evidenti.
Le conclusioni di Lanaro si racchiudono nell’interrogativo finale:
è possibile che l’Italia, che ha pagato sempre prezzi assai alti per diventare un
paese normale, possa diventarlo ora che è una potenza ricca e industriale, senza più la
guerra fredda?
Lanaro si segnala per una scrittura brillante, anche se qualche volta
complessa, per l’acume di molte intuizioni e osservazioni, per l’attenzione alla
società italiana vista nel quotidiano, nel sociale, nella vita economica. Queste sono
tutte qualità dell’opera che la rendono, come quella di Ginsborg, uno dei testi
fondamentali sull’Italia repubblicana.
Nel 1993, è uno storico che è stato a lungo comunista come Aurelio
Lepre a scrivere per Il Mulino la Prima storia della prima repubblica, che
successivamente con la seconda edizione arriva fino al 1994; Lepre sceglie una strada
diversa da Ginsborg e da Lanaro, quella di una sintesi che procede per grandi nodi e in
verità con qualche schematismo, cercando di tracciare, con notevoli capacità narrative,
le vicende essenziali del cinquantennio. Leggendo il libro di Lepre si è colpiti dal
fatto che ormai le periodizzazioni diventano nette e accettate dagli storici: il 1992
diventa l’anno della caduta del sistema politico repubblicano e l’inizio di una
lunga transizione tuttora in corso. Lepre è attento a proporre un racconto preciso degli
avvenimenti politici e istituzionali, oltre che di quelli economici, e dipana una serie di
problemi interpretativi che ritornano soprattutto nell’ultimo ventennio; su questo
ventennio non utilizza però una ricca letteratura che è disponibile e questo si può
considerare un difetto dell’opera.
Dal punto di vista interpretativo il lavoro si riallaccia per certi
versi alla Storia critica della repubblica, che un altro storico comunista, Enzo
Santarelli, pubblicherà un anno dopo presso Feltrinelli e che passerà pressoché
inosservata a livello critico. L’opera di Santarelli e quella di Lepre sono ambedue
delle storie politiche di buon livello, caratterizzate dalla consapevolezza del tramonto
repubblicano e dalla necessità di rivedere alcuni giudizi da lungo tempo depositati
soprattutto a sinistra.
Arriviamo al 1994, l’anno in cui per la prima volta una coalizione
di centrodestra, che comprende solo una parte dei cattolici, ottiene il potere soprattutto
per gli errori della sinistra. In quell’anno comincia a uscire un’opera
collettiva che vale la pena di discutere: è il primo volume della Storia
dell’Italia repubblicana pubblicata da Einaudi, che si conclude tre anni dopo,
nel 1997, e che è composta di tre volumi divisi in cinque tomi. In questo caso ci
troviamo di fronte a un’opera scritta da un gruppo di autori e da un comitato
scientifico composto da cinque storici, che pubblica in tre anni circa cinquemila pagine.
Il comitato scientifico si riunisce alla Fondazione Gramsci e alla rivista "Studi
storici" e comprende, oltre al sottoscritto, Franco Barbagallo, lo scomparso Franco
De Felice, Luisa Mangoni, Giuseppe Barone, Giorgio Mori, Mario Girossi e Giovanni Bruno.
L’impronta è quella di una storiografia che potremmo definire democratico -
gramsciana, con la caratteristica di puntare molto sul già citato nesso
nazionale/internazionale, sulle caratteristiche della divisione in due (nord-sud) del
paese, sul problema del rapporto comunismo/anticomunismo e fascismo/antifascismo.
L’impostazione si distacca dalle precedenti opere e tende a un
affresco variegato sull’ultimo cinquantennio, dedicando saggi approfonditi ai
problemi della politica, dell’economia, della cultura e delle istituzioni.
Naturalmente, come tutte le opere collettive, non è espressione di
un’interpretazione strettamente unitaria, anche se gli autori si riconoscono nel
filone che ho citato all’inizio. Nel complesso fornisce una grande miniera di dati e
di interpretazioni molto aggiornate sull’Italia dal 1943 a oggi.
Vorrei, per concludere, sottolineare da una parte i problemi aperti che
la storiografia successiva avrà davanti e dall’altra alcune peculiarità del cammino
che abbiamo già percorso. Tra i problemi aperti, il principale resta quello delle
istituzioni politiche e dell’economia, ma anche in questo campo ci sono ancora molti
aspetti da chiarire e da appronfondire, perché ci sono archivi importanti chiusi o
dispersi (penso ai servizi segreti, alla chiesa, agli archivi americani e sovietici, a
quelli dei partiti; per esempio, io ho fatto parte di una commissione nazionale che ha
trattato il problema del passaggio dell’archivio privato di Aldo Moro
all’archivio di Stato, per cui ho visto l’indice di questo archivio e posso dire
che è molto importante sulla storia politica italiana. Vi è però una clausola in base
alla quale l’archivio sarà consultabile solo fra ottanta anni).
C’è ancora molto da fare per costruire biografie significative di
politici, sindacalisti, uomini e donne di cultura; c’è da compiere
un’integrazione che ancora manca tra i risultati della storia locale e di quella
nazionale: il nostro è un paese che non si può raccontare da Roma soltanto, ma bisogna
raccontarlo nella sua complessa realtà. Ci vorrebbero gruppi di ricercatori che
utilizzassero le ricerche locali per dare un’immagine complessiva della storia
nazionale nel periodo repubblicano.
Inoltre, su settori importanti della nostra società (penso alle
associazioni, alla scuola, alla Chiesa, all’esercito, alla polizia), non si segnalano
ancora lavori scientifici, ma soltanto una pubblicistica anche ampia, ma non di rado
superficiale.
Credo di poter concludere affermando che molto lavoro è stato fatto,
ma molto resta ancora da fare e io mi auguro che lo facciano le nuove generazioni che
vorranno dedicarsi alla ricerca storica sull’Italia contemporanea.
(Intervento del 18 novembre 1997 per il corso di
aggiornamento "Storia dell’Italia repubblicana: dalla ricostruzione al boom
economico", organizzato dall’Istituto per la storia della Resistenza e della
società contemporanea di Asti)
|