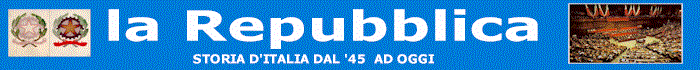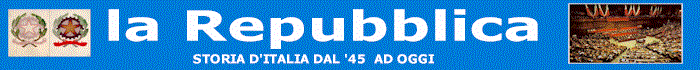|
Cent'anni di Savoia

 Carlo Alberto e i moti mazziniani Carlo Alberto e i moti mazziniani
Sale al trono nel 1831 in piena epoca di restaurazione. Il nuovo re non ha
una forte caratterizzazione. Figura complessa Carlo Alberto, si trova a vivere in
un periodo di transizione, senza un chiaro programma politico salvo l'odio per l'Austria,
il rispetto per la Chiesa e il desiderio di espandere i domini della sua casa. Nel 1821
aveva avuto una parte non molto chiara nei moti costituzionali avvenuti in Piemonte
(organizzati dal conte Santorre di Santarosa sulla scia dell'insurrezione
napoletana). Certamente egli era stato in contatto con i rivoltosi, ma all'ultimo si tira
indietro mentre i cospiratori, in buona o in mala fede, continuarono a contare su di lui.
In qualità di reggente aveva concesso la Costituzione nel 1821, ma il suo operato venne
presto sconfessato dal re Carlo Felice. I suoi atteggiamenti avevano destato sospetti non
solo nei carbonari - i quali lo accusarono di tradimento e per i quali divenne
"l'esecrato Carignano" (Berchet) - ma anche presso i suoi amici di un
tempo, agli occhi dei quali era reo di aver partecipato alla repressione della rivoluzione
liberare spagnola.
Sul trono Carlo Alberto dimostra subito grande rigore nel reprimere qualunque tentativo di
rivoluzione liberale, al pari dell'energia impiegata per riordinare lo Stato, risanare le
finanze e promuovere lo sviluppo economico del regno. Nello stesso periodo monta l'anelito
di libertà dallo straniero. Giuseppe Mazzini fonda a Marsiglia la "Giovine
Italia", associazione politica che operava clandestinamente, secondo un programma di
rinnovamento morale e politico degli Italiani ispirato a principi repubblicani. Mazzini
avvia nel 1833 il suo primo tentativo insurrezionale. La vastità della congiura e
l'aperta opera di propaganda, permettono però al governo sabaudo di venirne a conoscenza
ancora prima che essa venga attuata. La repressione di Carlo Alberto fu spietata e feroce.
Nonostante la vena reazionaria, determinata più dallo spirito conservatore dinastico che
da una effettiva concezione retrograda della politica, Carlo Alberto ha una sua teoria in
base alla quale gli unici due sovrani legittimi d'Italia sono i Savoia ed il Pontefice:
quando vede che quest'ultimo si schiera contro l'assolutismo e contro l'Austria ritiene
giunto il momento di divenire la "spada d'Italia". Comincia appoggiando
energicamente dapprima il Papa nel conflitto che questi ebbe con l'Austria per
l'occupazione di Ferrara (estate 1847) e quindi il Granduca di Toscana nella controversia
che questi ebbe con il Duca di Modena che era appoggiato da Vienna (autunno 1847).
Quando Ferdinando II, re di Napoli, concede la Costituzione, anche Carlo Alberto, il 4
marzo 1848, accorda, non senza crisi di coscienza e continui ripensamenti, lo Statuto
albertino, costituzione ricalcata sulla carta francese del '30, che istituisce il governo
costituzionale. Nello stesso mese scoppia a Milano il moto rivoluzionario antiasburgico,
noto con il nome di Cinque Giornate. Anche in questa occasione Carlo Alberto esita, ma
infine decide per l'intervento armato contro l'Austria. Dopo un primo successo l'esercito
piemontese perde rovinosamente a Custoza. Colpa anche della scarsa destrezza del re come
comandante e dell'incapacità del suo esercito. La sconfitta genera dubbi sulla lealtà
del re, il quale l'anno successivo, sotto la pressione dell'opinione pubblica, riprende la
guerra contro l'Austria. La campagna si risolve in soli tre giorni con la disastrosa
battaglia di Novara. Nella stessa giornata, il 23 marzo 1849, abdica in favore del figlio.
 Vittorio Emanuele II e l'unità d'Italia Vittorio Emanuele II e l'unità d'Italia
Un giovanissimo Vittorio Emanuele II si trova di colpo sul trono di
Sardegna, in un momento difficile per il paese. Impossibilitato a continuare la guerra,
firma l'armistizio con gli austriaci il 24 marzo 1849. Il nuovo re è un uomo debole, di
buon cuore e scaltro, ma rozzo e superstizioso, "possiede un carattere semplice, ma
ben poco del lustro e dello splendore della maestà regia". Alla maniera dei suoi
predecessori e di suo figlio poi, mantiene pubblicamente un'amante e dei figli
illegittimi, convinto che da un sovrano ci si attenda una cosa del genere. Come re
Vittorio Emanuele possiede una autorità più ampia della maggior parte dei monarchi
costituzionali. L'articolo 65 dello statuto stabilisce che il "Re nomina e revoca i
suoi ministri"; non ha nessun obbligo di seguire i loro consigli. Manifesta in più
di una occasione la volontà di esercitare l'autorità regia, se non al di fuori,
quantomeno all'estremo limite della correttezza costituzionale.
Nel 1850 Camillo Benso conte di Cavour diventa ministro, primo ministro nel
1852 e quindi a capo del governo quasi ininterrottamente fino al 1861. I rapporti tra i
due non sono sempre facili e cordiali, sebbene Cavour sia devoto alla monarchia. In ogni
caso il conte riesce a volgere a suo favore le ambizioni unitarie del re e, anche se
Vittorio Emanuele è portato per carattere ad intervenire ripetutamente negli affari di
governo, segue costantemente la politica di Cavour, così nel desiderio di restaurare la
fama del suo esercito come nel caso dell'intervento in Crimea. Gli anni più favorevoli al
regno di Vittorio Emanuele sono quelli dal '59 al '61. Partito in guerra contro l'Austria
nell'aprile del '59 -ottenendo la Lombardia - meno di due anni dopo è acclamato re
d'Italia da un Parlamento italiano. Alla rapida ascesa del monarca contribuisce in modo
determinante l'opera di Cavour e di Giuseppe Garibaldi che, con la spedizione dei
Mille, regala a Vittorio Emanuele II il grande regno meridionale; ma si deve riconoscere
che in questi anni decisivi Vittorio Emanuele II sposa fermamente la causa dell'unità
nazionale. Dopo il 1861 la posizione del re si indebolisce. Non è gradito ai repubblicani
e alle altre dinastie, private del trono. La terza guerra di indipendenza (1866) porta
alla corona il Veneto ma senza quella vittoria militare che il re desidera (la regione
viene ceduta alla Francia che ha l'incarico di consegnarla all'Italia). Inoltre, al
compimento dell'unità italiana mancava ancora Roma. Quando nell'estate del '70 scoppia la
guerra franco-prussiana, Vittorio Emanuele II è più propenso di accorrere in aiuto di
Napoleone III, antico compagno d'armi e di intrighi, ma si piega alla volontà dei suoi
ministri che vollero cogliere l'occasione propizia per attaccare Roma e occuparla. Nella
città si reca anche il re ma non si trova a suo agio. Non soggiorna mai al Quirinale
preferendo ritirarsi in una residenza più modesta, con la moglie morganatica Rosa
Vercellana, poi contessa di Mirafiori. Concluso il periodo eroico del Risorgimento, il
re è un sopravvissuto, come tanti altri protagonisti dell'indipendenza e
dell'unificazione. Nel 1876 vede allontanarsi dal governo per un voto contrario del
Parlamento la Destra storica dalla quale erano usciti i suoi ministri più abili ed i suoi
più fidati consiglieri. Ossequiente alle indicazioni del Parlamento, chiamò al governo
la Sinistra storica. Ciò avveniva nell'anno della sua morte.
 Umberto I e la repressione di Bava Beccaris Umberto I e la repressione di Bava Beccaris
Nel 1878 gli succede il figlio, Umberto I. Maggiore è il senso del
dovere e della dignità che Umberto dimostra rispetto al padre. Ma la situazione politica
italiana è complessa e non sempre il re sembra comprenderla. Intanto, in Europa,
l'equilibrio delle forze è cambiato: Umberto si predispone ad una riconciliazione con
l'Austria-Ungheria, forse perché la madre e la nonna sono principesse austriache. Ma alla
base ci sono anche ragioni più solide che consigliano di non spingere oltre le ostilità
tradizionali perché se la Francia dopo il 1870 è una repubblica sconfitta, quindi
indesiderabile come alleata, la Germania e l'Austria sono entrambe governate saldamente da
sovrani conservatori. Nel maggio del 1882 l'Italia diventa membro di secondo piano della
Triplice Alleanza: raramente riesce ad esercitare qualche influenza sulle azioni dei suoi
alleati ma psicologicamente il farne parte colma il desiderio italiano di prestigio.
Questo spinge l'Italia ad intraprendere una politica coloniale dispendiosa, pagata con
l'aumento delle imposte. In questo intreccio di autoritarismo e imperialismo emergono le
difficoltà incontrate dalla nascente nazione italiana in una fase di pesante congiuntura
economica e politica. L'aggravarsi della crisi agraria, l'espandersi della crisi edilizia
e i fallimenti della banche più esposte nel settore delle costruzioni fomentano la
ribellione che scoppia nel 1898: l'esercito guidato dall'ufficiale Bava Beccaris
interviene sedando la rivolta nel sangue.
L'impegno diretto di Umberto in politica estera lo rende impopolare non solo negli
ambienti che spingono per una riduzione dei bilanci militari, ma anche agli occhi degli
irredentisti ostili all'Austria. Re Umberto cade vittima di Gaetano Bresci, un
anarchico, nel luglio del 1900.
 Vittorio
Emanuele III e all'abbraccio con Mussolini Vittorio
Emanuele III e all'abbraccio con Mussolini
Sale al trono Vittorio Emanuele III. Fisicamente delicato, afflitto
da un complesso d'inferiorità, viene educato attraverso una rigida scuola militare, tale
da soffocare qualsiasi spunto di vitalità. Il nuovo re ha gusti più sobri rispetto al
padre, ma è anche più cinico e asociale e questo lo tiene lontano dal popolo.
Anticlericale e irreligioso, non viene apprezzato né dall'aristocrazia nera, né dalla
sinistra e neppure dalla società mondana. Il re è però un uomo di buon senso, modesto,
e questo favorisce un periodo di stabilità ed equilibrio almeno fino a che "il suo
amore per il quieto vivere non lo indusse a consegnare l'Italia ai fascisti".
Vittorio Emanuele non ha un rapporto di amicizia con Giovanni Giolitti (politico
progressista di spicco del panorama italiano dal 1890 al 1920; due volte alla guida del
governo, nel 1892 prima e nel 1908 poi) e con nessuno dei suoi ministri, si sforza però
di non apparire legato ad alcun gruppo. Questo permette il trascorrere di un periodo di
calma e relativa prosperità, avallato dalle riforme giolittiane.
La storia italiana subisce una svolta determinante quando nel panorama politico si fa
strada Benito Mussolini. Nell'ottobre del 1922 il governo Facta si avvia alle
dimissioni e la situazione volge a favore della compagine fascista. Il re rifiuta di
firmare lo stato d'assedio della città di Roma, meta della marcia compiuta dai fascisti.
Il suo rifiuto non è solo una violazione della prassi costituzionale, ma è il fondamento
del successo della marcia e dell'insurrezione. "Non v'è il minimo dubbio che il re
cambiò idea nel corso della notte. Il suo brillante cugino, il duca d'Aosta, che
forse aspirava segretamente al trono o comunque ad una posizione di primo piano, si era
installato nei pressi di Perugia e, a quel che si diceva, aveva poco tempo prima passato
in rivista i militi fascisti. Il re doveva pertanto andar cauto". E' la prima volta
che Vittorio Emanuele rifiuta di attenersi al parere dei suoi ministri che, per quanto
dimissionari, sono ancora in carica.Comincia così il ventennio fascista che travolgerà
anche la monarchia; Vittorio Emanuele teme troppo Mussolini e si chiama fuori da qualsiasi
decisione impegnativa che possa compromettere la dinastia (più volte Mussolini minaccia
"di farla finita una volta per tutte con la monarchia"). Il re segue il corso
degli eventi anche in questa occasione, senza prendere in considerazione la possibilità
di ribellarsi all'uomo che proprio lui ha chiamato al potere. La monarchia si macchia,
allo stesso modo del regime fascista dell'adozione delle leggi razziali prima e della
guerra poi. Ma il re si macchia anche di un'altra colpa grave, la fuga dopo l'8 settembre
1943. L'Italia è abbandonata a se stessa mentre il re scappa a Brindisi. Se il re avesse
abdicato nel 1943, la monarchia avrebbe avuto la possibilità di sopravvivere. Invece il
re respinge l'accusa di tradimento dello statuto sotto Mussolini, argomentando che un
sovrano costituzionale non ha nessuna responsabilità per le azioni dei suoi ministri e,
giustificando la fuga con la necessità di dare all'Italia una continuità di governo,
cosa che non sarebbe stata possibile se il re fosse caduto nelle mani dei tedeschi.
L'abdicazione giunge troppo tardi e Umberto II non è nelle condizioni di poter cambiare
quello che sarà il risultato del referendum: la vittoria della Repubblica e l'esilio dei
Savoia.
(Valeria De Rosa/grandinotizie.it)
 per approfondire: per approfondire:
Dossier
sui Savoia
I Savoia Storia, documenti,
biografie, colpe della dinastia (grandinotizie.it)
Fascismo e Savoia (anpi.it)
|