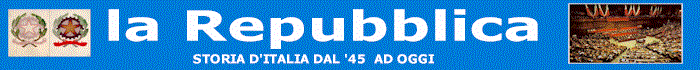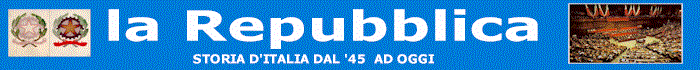|
1989, Tien An Men: la
storia
della Primavera di Pechino

di Sandro Viola
Nella notte tra il 20 e il 21 maggio 1989 la Trentottesima armata ebbe l'ordine di
marciare verso il centro di Pechino. Ma oltrepassate le periferie, quando già
s'avvicinavano al centro, i convogli dell'esercito si trovarono davanti un muro di folla.
Sin dall'alba, tutte le strade che portano al viale della Pace celeste e alla piazza
Tienanmen erano infatti ostruite da decine di migliaia di manifestanti che innalzavano
striscioni e cartelli di protesta contro il governo e il Partito comunista. I blindati e i
camion militari s'erano quindi dovuti arrestare, e i soldati ne erano discesi alla ricerca
dei pochi ritagli d'ombra dove ripararsi dal gran caldo. Così, attorno alle dieci del
mattino, l'atmosfera era ormai quella caotica, sfiduciata, d'un 8 settembre.
La truppa seduta sui marciapiedi, gli ufficiali ai telefoni per chiedere ordini che non
arrivavano, la catena di comando dell'Esercito popolare cinese (che all'epoca contava due
milioni e mezzo di uomini) evidentemente saltata.
Il giorno precedente, per bocca del primo ministro Li Peng, il governo aveva proclamato la
legge marziale. Proibizione di manifestare, coprifuoco. Ma era stato come parlare al
vento, non agli abitanti di Pechino. Tutto era infatti rimasto com'era ormai da quasi due
settimane: la piazza Tienanmen occupata da molte migliaia di studenti, e intorno alla
Tienanmen - il cuore del Potere - centinaia di migliaia di dimostranti, in certe ore un
milione, affluiti da ogni punto della capitale. E tutto questo senza alcuna reazione da
parte delle autorità.
La sensazione più diffusa era quindi quella d'uno stupefacente, impressionante vuoto di
potere. Il governo, e soprattutto il Politburo del partito, sembravano dissolti. Dalla
piazza Tienanmen si levava il fetore degli escrementi accumulatisi tra il mausoleo di Mao
Zedong, il monumento ai caduti e il palazzo dell'Assemblea del popolo, nei giorni
dell'occupazione condotta dagli studenti. E quel fetore costituiva un'onta atroce per la
dignità d'un regime che aveva dominato sulla Cina, temuto, indiscusso, negli ultimi
quattro decenni.
Un'onta, e l'annuncio della sconfitta. Perché il regime sembrava ormai non essere più
in grado di reagire alla rivolta studentesca e all'appoggio massiccio che era venuto alla
rivolta dagli abitanti della capitale.
Comincio da qui, dall'incredibile giornata del 21 maggio 1989, la rievocazione della
"primavera di Pechino", perché fu quel giorno che il comunismo parve anche in
Cina sull'orlo del collasso. Già liquidato in Polonia e ormai boccheggiante in Russia,
nei sei-sette mesi successivi il comunismo sarebbe caduto in Ungheria, nella Germania
dell'Est, in Cecoslovacchia, in Bulgaria, in Romania, e un po' più tardi in Albania. Quei
regimi vacillavano infatti da tempo, sempre più debilitati dalle penurie che imponevano
alle popolazioni e dall'assoluto discredito che circondava i loro gruppi dirigenti. Ma la
Cina era diversa. Un decennio di riforme economiche, una crescita del Pil che superava il
10 per cento annuo, un benessere ormai diffuso nelle aree urbane, e soprattutto un
apparato del potere ancora ferreo nel totale controllo della società, sembravano aver
messo il comunismo cinese al riparo da ogni brutta sorpresa.
Invece, improvvisa, inaspettata e travolgente, giunse la scossa più lunga, più ampia e
profonda di tutte quelle che s'erano già prodotte, e si sarebbero ancora prodotte durante
l'anno, nell'universo comunista. Tutto era iniziato verso la fine d'aprile, quando gli
studenti delle due università di Pechino erano scesi a migliaia nelle strade del centro
per commemorare la morte di Hu Yaobang, l'ex segretario del partito estromesso a causa
delle sue tendenze liberaleggianti. Ma fu il 13 maggio che gli studenti occuparono la
piazza Tienanmen. Due giorni dopo sarebbe dovuto infatti arrivare Mikhail Gorbaciov, e a
Pechino c'erano centinaia di giornalisti stranieri giunti ad assistere alla
riconciliazione (in realtà una Canossa sovietica) russo-cinese. I manifestanti, e coloro
che ai vertici del partito avevano deciso d'appoggiare la protesta, sapevano quindi che
quei giornalisti e telecamere costituivano una sorta di trincea che il governo e il
Politburo avrebbero evitato d'attaccare. Un migliaio di studenti s'accamparono così nella
piazza, e più di cento tra loro iniziarono uno sciopero della fame subito attorniati da
una folla enorme.
La visita di Gorbaciov ebbe aspetti da film comico. Le cerimonie solenni che avrebbero
dovuto aver luogo nel palazzo dell'Assemblea del Popolo, il cui ingresso è appunto sulla
Tienanmen, vennero cancellate dal programma. La comitiva sovietica entrava e usciva da
ingressi laterali, protetta da interi plotoni delle forze di sicurezza, e la conferenza
stampa finale di Gorbaciov dovette svolgersi nella palazzina dove i sovietici erano stati
messi ad abitare, e alla quale giunsero, avvertiti in ritardo, bloccati dalla marea di
folla che occupava le strade, pochissimi giornalisti.
Partita per Shanghai la delegazione sovietica, la situazione precipitò. Di primissimo
mattino, da est e ovest del viale della Pace celeste, confluivano fiumi di pechinesi che
andavano ad addensarsi nei pressi della piazza. Ormai, il tragitto dal mio albergo alla
Tienanmen, che ancora il 10-11 maggio percorrevo in venti minuti d'automobile, prendeva
tre ore. Era intanto divenuto sempre più chiaro che dietro agli studenti ci fosse una
fazione del partito, dato che migliaia di manifestanti giungevano a bordo di camion e bus:
e in Cina, a quel tempo, camion e bus non potevano circolare se non con l'autorizzazione
d'una qualche autorità.
Nella piazza, dalla massa studentesca era emersa nel frattempo una leadership: i Wan Dang,
i Wue Kaixi, i Cen Zuang, che parlavano con i giornalisti stranieri, componevano gli
slogan contro il nepotismo e la corruzione dei dirigenti, organizzavano i servizi, per
così dire, dell'occupazione. Passaggi liberi per le ambulanze, tende per i giovani che
facevano lo sciopero della fame, piccoli complessi rock per tenere alto il morale.
Ma il vertice comunista, che sembrava scomparso, era in realtà ormai pronto a reagire.
Zhao Zhiyang, il segretario del partito favorevole ad un dialogo con gli studenti, venne
dimesso. Attorno a Deng Xiaoping e al primo ministro Li Peng, che avevano deciso l'azione
di forza, si strinsero i vecchi conservatori, Chen Yun, Peng Zhen, Hu Qiaomu, Deng Liqun,
i vegliardi che due anni prima, al XIII congresso del partito, avevamo visto giungere alla
tribuna incespicanti, sorretti ai due lati dalle infermiere. Durato quasi un mese, lo
stallo nel Politburo era a questo punto superato. Si trattava solo di scegliere il momento
in cui, come aveva detto Deng, si sarebbero fatte "rotolare le teste".
Il 25 maggio ci fu l'ultimo, terribile insulto lanciato contro il potere comunista. Nel
pomeriggio ero sulla Tienanmen, quando da un lato della piazza, quello dinanzi
all'ingresso della Città proibita, si levò un coro di esclamazioni spaventate. Sulla
gigantografia del volto di Mao che pendeva (e ancora pende) sulla porta della Pace
celeste, erano stati scaraventati numerosi barattoli di vernice nera, gialla, rossa, e la
faccia del Grande Timoniere appariva imbrattata, profanata come nessun cinese avrebbe mai
immaginato di vedere.
Intanto la Trentottesima armata, che non era riuscita a superare il muro della folla per
raggiungere il centro di Pechino, era stata sostituita dalla Ventisettesima. Una grossa
parte degli studenti sentirono che il dramma era ormai incombente, e lasciarono la
Tienanmen. Attorno alla Dea della democrazia, una sagoma femminile in gesso e cartapesta
che i manifestanti avevano costruito ispirandosi alla statua della Libertà, rimasero
1.000-1.500 giovani. Almeno trecento dei quali, quando nella notte tra il 3 e il 4 giugno
la Ventisettesima attaccò la piazza, vennero trucidati dalle raffiche dei mitragliatori.
(la Repubblica 31
maggio 2009) |