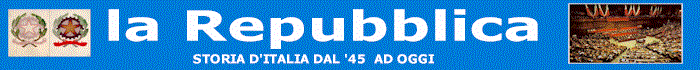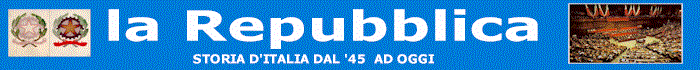|
1949: L’ITALIA ADERISCE
AL PATTO ATLANTICO
De Gasperi e la DC nella politica
estera italiana
di Carmelo Caruso
Negli anni immediatamente successivi alla
seconda guerra mondiale, l’Italia sceglie di orbitare nell’area delle potenze
occidentali. Si tratterà di un’adesione molto più problematica di quanto possa
apparire in superficie, non solo per la strenua opposizione portata avanti dalle sinistre,
ma anche per le divisioni sorte in seno alla stessa DC, in cui, alcune componenti – in primis i Dossettiani – criticarono le
scelte internazionali del governo.
Accanto a queste resistenze di carattere
“interno”, Il governo dell’epoca dovette confrontarsi prima con i veti
posti al suo ingresso nel Patto da parte di Stati Uniti e Francia, così come di Regno
Unito, Canada, Belgio. I governi di questi paesi ritenevano che l’estensione verso il
Mediterraneo dell’Alleanza, concepita per le potenze “rivierasche” (che in
altre parole si affacciavano sull’Atlantico del Nord) avrebbe condotto ad uno
snaturamento di quest’ultima, la avrebbe indebolita e molti altri stati avrebbero
potuto seguire l’esempio italiano. Secondo quanto scrive Nico Perrone, fu grazie alle
pressioni esercitate dall’ambasciatore Tarchiani e dal ministro degli esteri, Sforza,
che si potè superare l’impasse.
In piena sintonia con le aspirazioni italiane, e del Presidente del Consiglio De Gasperi
era invece J. D. Hickerson, direttore dell’Office of European Affairs del
Dipartimento di Stato, che concepiva l’allargamento del Patto come uno strumento di
lotta anticomunista.
In cosa consisteva esattamente il Patto
atlantico? Si trattava di un’ alleanza difensiva proposta dall’amministrazione
Truman, sintomo della nascente contrapposizione tra i blocchi nella guerra fredda. Essa
realizzava la dottrina elaborata dal presidente americano, fondata sul containment, cioè sul contenimento e la risposta
rapida all’avanzata sovietica. I firmatari sarebbero dovuti intervenire in difesa di una delle parti aggredite,
nel caso in cui vi fosse stato un attacco da parte di una potenza esterna.
L’ipotetico destinatario di di questa disposizione era l’Unione Sovietica, in
quanto l’Urss rappresentava “l’unico possibile aggressore, nell’area
garantita dal trattato”.
Per l’Italia, d’altra parte, l’adesione al patto avrebbe implicato alcuni
vantaggi, e, soprattutto, il prestigio che sarebbe conseguito dall’essere ammessi al club delle potenze filoamericane. Si trattava, in
altri termini, di reintegrare l’Italia nelle relazioni internazionali.
Il Parlamento italiano, si pronunciò
favorevolmente all’adesione, confermando le aspirazioni di De Gasperi; tuttavia, come
si scriveva poco sopra, si trattò di un’adesione sofferta. Lo fu per De Gasperi in
particolare, le cui posizioni in politica estera furono la conseguenza di una valutazione
ponderata tra i vantaggi promanati e i costi politici di una simile scelta; e
l’Italia, costituì un alleato non sempre ligio alle direttive americane, poiché,
come afferma Mario Del Pero, “la consapevolezza dei vantaggi derivanti da un legame
più stretto con gli Stati Uniti maturò lentamente e non senza distinguo.”
Per questo motivo, si può supporre che De Gasperi considerasse l’opzione atlantica
come l’unica alleanza concretamente praticabile nel contesto storico e politico del
immediato secondo dopoguerra; ma, questo avvenne non per una presunta affinità ideologica
con l’alleato d’oltreoceano, bensì per motivi strategici e programmatici.
Infatti, se la Russia stalinista costituiva un modello antidemocratico e inevitabilmente
lontano, non si può affermare al contempo che l’utilitarismo
consumistico degli Usa fosse in profonda sintonia con un partito come la DC, orientata
verso valori tradizionali, propri di un paese non ancora aperto alle innovazioni della
società.
Ma anche alcuni settori del partito di
maggioranza videro negativamente quest’operazione. La DC, infatti, in quanto
“contenitore” di diversi orientamenti, registrò alcune difformità rispetto
all’indirizzo generale del Governo. In linea di massima erano presenti tre correnti:
i Dossettiani, neutralisti, che costituivano la sinistra del partito; i Gronchiani, che
invece propendevano per il “terzaforzismo”, ossia per una posizione
d’equilibrio tra Patto atlantico e COMECON,
in cui all’Italia e all’Europa sarebbe spettato un ruolo di mediazione e
autonomia; mentre altre componenti del partito erano favorevoli
all’ingresso nell’alleanza. Nella primavera del 1949, tale dibattito divenne
veramente acceso, coinvolgendo figure come Gedda, e sul versante opposto don Primo
Mazzolari e Igino Giordani.
Dopo la ratifica del Patto, De Gasperi
seppe mediare con gli alleati, evitando conseguenze troppo impegnative. Così accadde, per
esempio, nel 1950, quando, allo scoppio della guerra di Corea, il Governo italiano inviò
una sola unità d’ospedale da campo.
Da questa scelta si comprende quali erano le intenzioni dello statista trentino:
coinvolgere il Paese in un circuito politico di gran rilievo, con tutti i conseguenti
frutti, senza compromettersi troppo, sebbene la questione delle basi statunitensi avesse
creato un’accesa polemica attorno alla questione della sovranità nazionale.
|