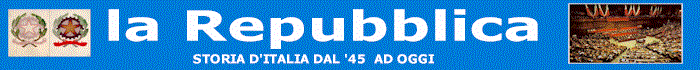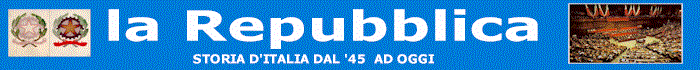|
Il miracolo
economico
2. Segni e squilibri del sistema
Uno sviluppo così repentino in un paese ricco di ritardi e
contraddizioni di vecchia data non poté non generare (ed ereditare) una serie di “distorsioni”:
innanzi tutto la diffusione del benessere per i cittadini era in netto ritardo rispetto
alla velocità del progresso tecnologico. Il “miracolo economico” si affermò in
un sistema dove dominavano le libere forze del mercato e le cui peculiarità sembravano
essere il già menzionato mutamento merceologico dell’offerta dei mezzi di trasporto
e degli elettrodomestici, la progressione costante dei salari, l’intensificazione
della combattività operaia, un’impennata dei consumi privati
e le migrazioni interne. Ciascuno di questi fenomeni da un lato generò forti scompensi e
rotture, dall’altro produsse bisogni a cui il sistema non era in grado di sopperire
(ad esempio per ciò che riguardava la domanda aggiuntiva di abitazioni, scuole,
ospedali).
Questi fenomeni di “distorsione”, secondo le tesi di
Sapelli e Salvati, sono riconducibili ad alcuni problemi strutturali dell’Italia a
partire dal dopoguerra: il dualismo della struttura produttiva industriale ed il permanere
della “questione meridionale”.
Secondo Sapelli, in Italia c’era una situazione di netta differenziazione (appunto
dualistica) dello sviluppo economico tra i settori dinamici ad alto tasso di innovazione
orientati quasi esclusivamente all’esportazione (industrie automobilistiche, chimiche
e siderurgiche) e settori arretrati e tradizionali destinati a soddisfare la domanda
interna (settore tessile, alimentare ed edile). I vari settori produttivi avevano
beneficiato in modo del tutto diverso dell’influsso dei vantaggi offerti dalla
favorevole congiuntura economica: l’aumento della produttività, l’allargamento
delle economie di scala, la redistribuzione delle risorse e l’apertura verso i
circuiti di scambio internazionale. Così aumentò in modo sensibile la distanza tra
grande e media industria (principali beneficiari degli aiuti statali e delle varie
economie esterne) e la piccola impresa espulsa dai settori chiave della produzione e gravata di maggiori costi di finanziamento del ciclo produttivo e
di inserimento nei commerci extralocali. Le conseguenze di questo dualismo si resero
evidenti sia nel regime d’occupazione che nelle forme di lavoro e nella distribuzione del reddito.
Nel mercato del lavoro si assisteva ad un notevole aumento di
produttività unitamente a bassi incrementi occupazionali nei settori più avanzati e
dinamici, mentre quelli più arretrati assorbivano gran parte della disoccupazione,
promuovendo bassi incrementi di produttività e rilevanti incrementi occupazionali.
Una delle principali attrattive dei rami più sviluppati fu sicuramente la possibilità di
offrire un monte salari superiore a quello delle altre industrie e a volte anche una serie
di facilitazioni per i suoi addetti.
Ma Graziani fa notare come, seppure i salari nell’industria trainante crescessero
più di ogni altro, uno dei segreti del boom economico fu il fatto che in rapporto all’“accumulazione”
di capitale ottenuta con l’aumento della produzione e della produttività operaia
(aumentata di oltre un terzo), i salari reali nell’industria diminuirono.
Il boom economico aveva permesso un elevato tasso dei profitti, questi, a loro volta,
favorirono un incremento degli investimenti
pubblici e privati. Tale incremento produsse in Italia accese discussioni, anche a livello
politico, sull’utilizzo di questi investimenti: vi era chi sosteneva che gli
imprenditori ne avessero fatto un uso principalmente qualitativo, ossia finalizzato alla
modernizzazione degli impianti ed all’aumento della produttività. Altri, in
particolare la sinistra, ritenevano che gli imprenditori non avessero usato tali
investimenti per ampliare la base del sistema bensì per aumentare i loro stessi profitti.
Negli anni di questo “inusitato sviluppo” l’agricoltura
e la piccola industria, insieme all’edilizia e al piccolo commercio, svolsero un
ruolo di “polmone della disoccupazione”:
furono cioè un serbatoio di manodopera sottoccupata e sottoremunerata, caratterizzata
dagli elevati indici di occupazione precaria e bassi livelli salariali e sindacali. E’
possibile affermare che all’espansione di settori trainanti corrispose una continua
proliferazione dei settori più o meno arretrati, si creò così una frammentazione
sociale ed economica del paese destinata ad aggravarsi.
Il problema della distorsione dei consumi derivò in parte dallo stesso dualismo dell’economia
italiana di quel periodo: i settori più dinamici e forti (come il petrolchimico che
nacque tra gli anni Cinquanta e Sessanta e che ebbe tra i suoi principali esponenti la
Montecatini, la Sir e la Edison) tendevano a modellare la propria produzione sulla falsa
riga di quella estera. Questo aspetto spiega, secondo G. Crainz, perché in un paese
caratterizzato da un incremento assai modesto del consumo interno e del reddito procapite
fossero diffusi modelli e strutture di beni di consumo tipici di un economia più moderna.
Inoltre vi fu anche un aspetto legato al fatto che l’intervento pubblico fu spesso
limitato alla costruzione di infrastrutture funzionali sopratutto alle esigenze di
espansione dei nuovi mercati e del padronato imprenditoriale più forte: ciò fu una delle
cause della diffusa arretratezza dei servizi pubblici essenziali come la sanità e la
scuola.
Sapelli ha fatto notare come il problema non risiedesse nella grande diffusione dei
consumi (comunque favorita da un incremento generalizzato dei redditi in una condizione di
assenza dell’inflazione), ma nella composizione e nella tipologia dell’offerta
che escludeva i beni fondamentali ed i sevizi. Inoltre,
i prezzi svolsero un ruolo discriminate: i prodotti di consumo meno cari erano proprio
quelli superflui, mentre quelli economicamente più dispendiosi erano quelli ritenuti
basilari come i trasporti pubblici o i libri.
Parlando degli squilibri del “sistema Italia” non si può
dimenticare una grande disfunzione costituita dall’arretratezza del Mezzogiorno. Il
meridione italiano era arrivato all’appuntamento con il boom avendo un’economia
ancora prevalentemente agricola dove gli occupati in questo settore rappresentavano il 40%
del totale dei lavoratori contro il 30% della media nazionale nel 1960 (se si escludono
alcune limitate zone, la maggior parte della superficie agricola era ancora occupata da
una cultura di tipo estensivo). Il latifondo era la forma di gestione predominante e la
pressione demografica continuava a mantenersi elevata; lo sviluppo industriale era
completamente insufficiente e basato soprattutto sulle piccole imprese a carattere
semiartigianale.
Con il “miracolo” nel paese si ampliò maggiormente la differenza di sviluppo
delle diverse zone. Le strategie dell’imprenditoria nazionale, tentando un’integrazione
nel tessuto economico dei paesi più avanzati, contribuirono ad ampliare questa forbice;
infatti le esigenze di competitività e di agganciamento agli standard produttivi
internazionali avevano portato ad una concentrazione degli investimenti verso i distretti
industriali del Nord, che già presentavano uno sviluppo piuttosto avanzato. In quest’ottica
uno spostamento di capitali verso il Sud avrebbe significato disperdere tecnologie e
risorse.
Il Meridione, nel boom economico, era destinato ad avere una funzione subordinata e
funzionale agli interessi dell’economia del Nord.
Nonostante la condizione di diffusa e radicata arretratezza
nelle terre del Mezzogiorno costituisse per l’economia italiana
un ostacolo difficilmente integrabile dal sistema “consumista-fordita”,
essa comunque presentava una serie di indiscutibili vantaggi.
Tra questi vantaggi possiamo annoverare il ruolo di riserva di
manodopera rappresentato dalle campagne meridionali per un Nord che, tendendo verso la
“piena occupazione”, esigeva nuove risorse di manodopera;
inoltre, l’assenza effettiva di un’industrializzazione nel meridione costituiva
una garanzia per i grandi gruppi economici del Nord, contro ogni possibile concorrenza
interna. Ma, come detto, la situazione meridionale per altri aspetti costituiva anche un
ostacolo allo sviluppo dell’industria settentrionale che, proprio per il modello
economico che aveva deciso di seguire, doveva necessariamente espandere il proprio mercato
interno anche in quelle zone in cui persistevano forme di autoconsumo e bassissimi redditi. Lo stesso settore agricolo, a
causa dei suoi bassi livelli di produttività e incapacità di potere rispondere alle
nuove richieste di un’economia sempre più internazionale, non permetteva a molti
prodotti italiani di essere competitivi. Come visto, il governo italiano, decidendo di
avvallare un modello di sviluppo “consumista-fordista”, si fece promotore di una
politica di “intervento” al fine di porre rimedio ai problemi del Sud. Il
governo agì attraverso due vie principali: la Riforma agraria e la Cassa per il
Mezzogiorno.
In particolar modo, le aspettative di industrializzazione del Sud furono legate alle
iniziative della Cassa (creata nel 1950): l’Istituto aveva il compito di promuovere e
sviluppare, attraverso agevolazioni fiscali e incentivi economici, la crescita di un
settore industriale efficiente e autopropulsivo. I primi tentativi di creare un’occupazione
diffusa puntavano da un lato al coinvolgimento delle piccole-medie imprese e dall’altro
alla creazione di quelle opere infrastrutturali che avrebbero dovuto funzionare da volano
per l’economia.
Con l’arrivo del boom economico il governo decise di cambiare rotta e di porre
rimedio ai limiti della sua azione relativa alla prima metà del decennio (come ad esempio
l’eccessiva dispersione dei fondi, l’eccesso di centralizzazione nella gestione
della Cassa e l’eccessivo privilegio dato allo sviluppo della agricoltura rispetto a
quello dell’industria).
Graziani sottolinea come fosse ormai palese che questa forma di intervento, basata su
criteri più umanitari che propulsivi, rappresentasse uno spreco e non servisse per un
effettivo decollo dell’industria; come avrebbe avuto a dire la famosa economista
inglese Vera Lutz: “le strade costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno servivano
oramai agli abitanti… soltanto per abbandonare per sempre i loro paesi di origine”. Il governo considerò ragionevole porre termine
alla politica di carattere umanitario per avviarne una nuova più aderente alla situazione
reale, quella del “miracolo economico”. Due furono i criteri ispiratori di tale
politica:
·
sotto il profilo
settoriale si decise di realizzare una svolta in favore dell’industrializzazione.
Tale scelta comportò non solo uno spostamento di fondi verso quel settore, ma anche un
nuovo orientamento nella politica delle opere pubbliche fatte in modo che risultassero
completamente funzionali allo sviluppo dei nuovi insediamenti industriali. Tuttavia la
nuova politica industriale venne concepita nel quadro dell’ipotesi in base alla quale
la crisi endemica della disoccupazione del Sud potesse trovare una risoluzione solo al di
fuori dai suoi confini. Si pensò infatti che lo sviluppo industriale avrebbe dovuto
svolgere anzitutto la funzione di accrescere l’efficienza del sistema produttivo
meridionale, attraverso l’aumento del reddito e della produttività del lavoro.
Non sembrò essenziale che l’industrializzazione dovesse risolvere anche il problema
della disoccupazione. Inoltre, come ha
sottolineato E. Scalfari nel libro “Razza padrona”, nella nuova campagna di
industrializzazione del Sud le imprese a capitale pubblico (come ad esempio l’ENI di
Enrico Mattei) ebbero un ruolo dominante e
rappresentarono lo strumento favorito dalla Stato.
·
Sotto il profilo
territoriale, gli interventi prevedevano la creazione di un insieme di “aree e di
nuclei di sviluppo industriale” che avrebbe dovuto porre fine agli sprechi e alle
dispersioni del primo periodo. L’evento
che sanzionò e tradusse in pratica questa svolta fu l’emanazione della legge 643 del
luglio 1957 che intendeva disciplinare l’istituzione delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale. “All’obbligo…per le amministrazioni dello stato di
riservare a imprese meridionali il 30% delle forniture e lavorazioni loro occorrenti….si
aggiunse l’obbligo per le amministrazioni statali di riservare al Mezzogiorno il 40%
dei propri investimenti. Si stabilì inoltre che le imprese a partecipazione statale
dovessero ubicare nel Mezzogiorno una quota minima, pari al 60%, dei nuovi impianti che
comunque dovevano essere ubicati nel Mezzogiorno non meno del 40% del totale degli
investimenti eseguiti”.
L’impegno profuso e le somme investite nell’iniziativa
furono elevatissime ma non riuscirono ad intaccare la cause dell’arretratezza della
società. Uno dei limiti degli obbiettivi delle politiche di intervento statale nel Sud fu
quello di voler ottenere un elevamento appena sopra la soglia di sussistenza della
popolazione meridionale ma le esigenze della nuova moderna società dei consumi erano
molto superiori e tale condizione non avrebbe certo potuto fermare l’emorragia di
popolazione.
Inoltre il governo, nella gestione della Cassa, si era dimostrato troppo subalterno alle
esigenze dei grandi monopoli privati; infatti, i finanziamenti concessi al Sud per la
costruzione di infrastrutture ed altri edifici, che giungevano in gran parte dal Nord del
paese, spesso finivano alle ditte fornitrici e alle imprese di costruzioni settentrionali
che svolgevano i lavori, inoltre la maggior parte dei prodotti delle nuove industrie
meridionali non erano destinati al mercato interno ma a quello del Nord o a quello
europeo.
Il fallimento dell’intervento straordinario coincise con quello delle sue principali
istituzioni: la Riforma agraria e la Cassa per il Mezzogiorno. Per quello che riguarda in
modo particolare l’insuccesso della Cassa, si può affermare che questa non fu capace
di tradurre in pratica uno dei suoi compiti più importanti, ossia quello di riuscire ad
essere uno strumento capace di spezzare l’immobilismo dell’economia meridionale
finendo spesso per sostituirsi semplicemente alla gestione ordinaria anziché aggiungersi
ad essa. Inoltre, gli investimenti realizzati nel settore industriale non riuscirono a
dare i risultati sperati a causa di scelte strategiche errate, per di più, spesso, alle
grandi aziende locali, per diverse motivazioni, non interessava promuovere lo sviluppo
locale.
 torna all'indice generale torna all'indice generale
Ivi. Il ciclo “consumista-fordista”, in cui
Italia era entrata, si basava su due pilastri principali
costituiti dagli alti consumi e dalla larga diffusione di tutti quei prodotti
propri di una società opulenta. La presenza
di questa società opulenta, sul falsa riga del modello americano, era necessaria perché
proprio per le sue caratteristiche era in
grado di sorreggere e rigenerare questo tipo di mercato.
|