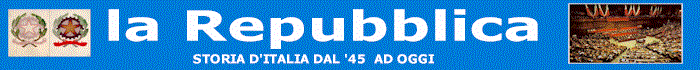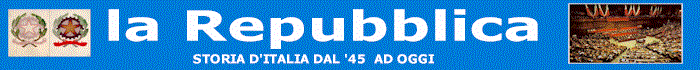|
Biografia
 Adriano Olivetti Adriano Olivetti

Imprenditore. Ebreo, nato ad Ivrea l'11 aprile del 1901, da Camillo, primo
di sei figli. Il padre, ingegnere eclettico e geniale, nel 1908 aveva fondato a Ivrea
"la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere". Adriano, negli anni della
formazione, è molto attento al dibattito sociale e politico; frequenta ambienti liberali
e riformisti, collabora alle riviste "L'azione riformista" e "Tempi
nuovi" ed entra in contatto con Piero Gobetti e Carlo Rosselli. Dopo essersi laureato
in chimica industriale al Politecnico di Torino, nel 1924 inizia l'apprendistato
nell'azienda paterna come operaio. L'anno seguente, accompagnato da Domenico Burzio,
compie un viaggio di studi negli Stati Uniti, dove visita un centinaio di fabbriche. uesto viaggio fu fondamentale non solo
per la sua professione, ma anche per la sua vita. Quando tornò, per due anni approfondì
l’esperienza leggendo casse di libri sul miracolo economico, sull’organizzazione
scientifica del lavoro, sui sistemi per incrementare la produttività e sul segreto che si
celava dentro le industrie, veri “templi” dell’America dei primi anni
‘20. Arrivò così a capire che la produttività delle industrie americane era dovuta
all’applicazione rigorosa di metodi scientifici di organizzazione del lavoro ad ogni
problema dell’azienda. Grande lezione gli fu data dalla visita agli stabilimenti Ford
di Highland Park, dove ebbe occasione di entrare in contatto con la filosofia fordista:
“My life and work”, scritto appunto da Ford. Egli aveva rivoluzionato il
sistema, raddoppiando di colpo il salario ai suoi operai e trasformandoli così in
consumatori, innescando una spirale di ricchezza che portò al miglioramento della vita di
molte persone. Dopo questo viaggio, e con il modello paterno, anche Adriano iniziò a
vedere nella fabbrica, che prima sentiva fredda e ostile, un mezzo per diffondere i suoi
ideali ed inverare le proprie convinzioni. Ritornato ad Ivrea iniziò subito a
sperimentare il Taylorismo, altrimenti detto O.S.L., (Organizzazione Scientifica del
Lavoro). Naturalmente non importò il modello tout court, ma lo adattò al contesto
italiano, ricavandone il massimo vantaggio non solo per la produttività, ma anche in
considerazione delle esigenze degli operai. Adriano, aiutato dalla nuova generazione di
ingegneri entrati in fabbrica, istituì l’Ufficio Tempi e Metodi. L’elemento
peculiare fu l’introduzione della figura dell’allenatore, a fianco a
quella del cronometrista, ossia di un operaio medio che in collaborazione col
cronometrista – metodista, studiava dapprima il posto di lavoro suggerendo modifiche
e strumenti specifici e, solo dopo questa razionalizzazione, dimostrava i tempi di fase,
lavorando lui stesso per un certo periodo. I benefici erano indubbi sia per l’operaio, che
raggiungeva senza eccessiva difficoltà i tempi richiesti, sia per la qualità del
prodotto finito e l’uniformità delle linee.
Dal 1926 al 1932,
l’azienda Olivetti subì una trasformazione totale, con l'adozione di una miriade di
provvedimenti in favore dei dipendenti e di un vasto programma di progetti e
innovazioni per modernizzare l'attività della Olivetti: organizzazione decentrata del
personale, direzione per funzioni, razionalizzazione dei tempi e metodi di montaggio,
sviluppo della rete commerciale in Italia e all'estero, ecc.. In seguito avvia anche il progetto
della prima macchina per scrivere portatile che uscirà nel 1932 con il nome di MP1.
La nuova organizzazione fa aumentare in maniera significativa la
produttività della fabbrica e le vendite dei prodotti. Nel 1931 compie un viaggio in URSS
con una delegazione di industriali italiani. Nello stesso anno introduce in Olivetti il
Servizio Pubblicità, che fin dagli inizi si avvale del contributo di importanti artisti e
designer; l'anno seguente istituisce l'Ufficio Organizzazione.
Alla fine del 1932 è nominato Direttore Generale dell'azienda, di cui diventerà
Presidente nel 1938 subentrando al padre Camillo. Porta avanti riflessioni e
sperimentazioni nel campo dei metodi di lavoro e pubblica, nella rivista da lui fondata,
"Tecnica e Organizzazione", vari saggi di tecnologia, economia, sociologia
industriale.
La sua poliedrica personalità lo porta a impegnarsi non solo nel campo strettamente
industriale e imprenditoriale, ma ad occuparsi anche di problemi di urbanistica, di
architettura, di cultura, oltre che di riforme sociali e politiche. A Ivrea avvia la
progettazione e costruzione di nuovi edifici industriali, uffici, case per dipendenti,
mense, asili, dando origine ad un articolato sistema di servizi sociali. In particolare,
nel 1937 dà l'avvio alla costruzione di un quartiere residenziale per i dipendenti, su
progetto degli architetti Figini e Pollini.
Adriano ha ereditato dal padre il senso innato di giustizia, la
convinzione dell’uguaglianza di tutti gli uomini, il diritto alle pari opportunità,
l’istintività. Ecco perché usando lo strumento che ebbe a disposizione:
l’Olivetti, cerca di creare le condizioni concrete per poter realizzare una società
più giusta, dove la democrazia ed il socialismo fossero reali. Cerca con ogni mezzo in
suo possesso di supplire alle carenze legislative, politiche ed economiche di cui erano
vittime le classi più disagiate ed ai margini della società civile. Durante la sua vita
scrive tre libri. “ L’Ordine politico delle Comunità”, nel 1947;
“Società, Stato, Comunità”, nel 1952 e “Città dell’uomo”, nel
1960. In tutti e tre, cerca di tracciare un percorso comune, un filo conduttore, nel
delineare il “suo progetto”: una comunità che fosse interprete delle condizioni
per il benessere delle persone e non solo per il soddisfacimento dei suoi bisogni.
Idee rivoluzionarie le sue. E' infatti spiato dalla polizia fascista che
nel fascicolo a lui dedicato lo bolla come "sovversivo". Non a torto. Ha contatti
con Maria Josè e i servizi segreti americani. Dopo la caduta del fascismo, è arrestato
da Badoglio perché cerca di avvertire gli Usa di non fidarsi di lui. Tornato libero,
rimane per un po' in clandestinità, poi ripara in Svizzera. Durante l'esilio in Svizzera
(1944-1945) collabora con la Resistenza, frequenta assiduamente Altiero Spinelli, teorico
dell'unità europea, e completa la stesura del libro "L'ordine politico delle
comunità", pubblicato alla fine del 1945 dalle edizioni NEI. Vi sono espresse le
idee alla base del Movimento Comunità, che fonda nel 1947, con una serie di proposte
intese a istituire nuovi equilibri politici, sociali, economici tra i poteri centrali e le
autonomie locali. La rivista "Comunità", che inizia le pubblicazioni nel 1946,
diventa il punto di riferimento culturale del Movimento. Alla fine del '59 le Edizioni di
Comunità pubblicheranno una raccolta di saggi di Adriano Olivetti sotto il titolo
"Città dell'Uomo".
Nel dopoguerra si candida alle elezioni politiche del 1953 insieme con le
liste di Unità Popolare di Ferruccio Parri e Piero Calamandrei
Per tradurre le idee comunitarie in realizzazioni concrete, nel 1955 fonda
l'IRUR - Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale del Canavese - con l'obiettivo di
combattere la disoccupazione nell'area canavesana promuovendo nuove attività industriali
e agricole. L'anno seguente il Movimento Comunità si presenta alle elezioni
amministrative e Adriano Olivetti viene eletto sindaco di Ivrea. Il successo induce
Comunità a presentarsi anche alle elezioni politiche del 1958, ma risulta eletto il solo
Adriano Olivetti. E' poi fondatore e presidente della Lega dei Comuni del Canavese. La sua
posizione, oggi diremo di Terza Forza e Terza Via, nel clima duro di scontro della Guerra
Fredda trovò una strenua resistenza nel mondo cattolico torinese, nonostante Olivetti
fosse cattolico e fosse l'unico a valorizzare in Italia il personalismo comunitario di
Mounier, che si riconosceva al massimo nelle punte più avanzate della sinistra Dc. Un'opposizione
analoga incontrò nel Psi e nel Pci che lo riteneva solo un imprenditore paternalista,
nonostante il suo passato limpidamente antifascista. Eppure Olivetti appare come un
socialista umanitario, pre-marxiano, utopista come lo furono gli imprenditori Owen e
Saint-Simon che cercavano di attuare nelle proprie aziende le proprie avanzate teorie
politiche e sociali, come Proudhon teorico di un ordinamento non statalista, he
valorizzava le comunità locali e di lavoro.
Colpisce che Adriano Olivetti abbia voluto con sè una miriade di persone
che poi si sarebbero qualificate con il termine un po' sbrigativo di 'intellettuali in
fabbrica'. Ciò che è importante rimarcare è che queste persone non vennero a costituire
quella che taluno avrebbe poi definito come la 'corte del principe'; al contrario, furono
assunte al preciso scopo di enucleare e condurre specifiche funzioni aziendali: dalle
relazioni interne (Franco Momigliano, per esempio) alla comunicazione (Leonardo
Sinisgalli, Ignazio Weiss, Carlo Brizzolara, Libero Bigiaretti, Renzo Zorzi e via
dicendo), dall'elaborazione dei testi pubblicitari (Franco Fortini, Giorgio Soavi ed
altri) alla grafica pubblicitaria (Xanti Schawinsky, Costantino Nivola, Salvatore Fiume,
Giovanni Pintori, Egidio Bonfante e così via), dal design dei prodotti (Aldo Magnelli,
Marcello Nizzoli ed i loro successori), alle architetture olivettiane: architettura per i
luoghi del lavoro e per quelli della residenza, per i servizi sociali di fabbrica e per
quelli destinati alla comunità; né si dimentichi l'allestimento degli stand Olivetti
nelle principali fiere internazionali e le famosissime architetture di interni dei negozi
Olivetti (GianAntonio Bernasconi, Ugo Sissa, Carlo Scarpa, BBPR, Leo Lionni e Giorgio
Cavaglieri per citarne alcuni).
Basterà poi un solo e breve cenno per ricordare che in Olivetti, dietro diretto impulso
di Adriano, si sarebbero affermate - sempre a supporto delle scelte aziendali in momenti
decisivi - discipline che solo in epoca più tarda avrebbero trovato nel nostro paese una
consacrazione anche accademica: l'economia di impresa (ancora con Franco Momigliano), la
sociologia industriale (Luciano Gallino e la sua scuola), la psicologia del lavoro (Cesare
Musatti ed i suoi allievi).
Adriano detestava essere definito «un padrone illuminato» anche se
arricchì la fabbrica delle tecniche più aggiornate dell’organizzazione del lavoro.
In anticipo sul proprio tempo ebbe contro di sé gran parte dell’establishment
capitalista e marxista. Pose per primo i problemi dell’ambiente, della tutela del
territorio e dell’equilibrio ecosistemico. Mise in guardia sulla natura non infinita
delle risorse naturali.
Urbanista, editore, scrittore, uomo di cultura; ma Adriano Olivetti è soprattutto un
industriale e un imprenditore che crede nell'impresa come vero motore dello sviluppo
economico e sociale.
Sul piano aziendale, guida la Olivetti verso gli obiettivi dell'eccellenza tecnologica,
dell'innovazione e dell'apertura verso i mercati internazionali, dedicando particolare
cura anche al design industriale e al miglioramento delle condizioni di vita dei
dipendenti.
Nel 1948 negli stabilimenti di Ivrea viene costituito il Consiglio di Gestione, per molti
anni unico esempio in Italia di organismo paritetico con poteri consultivi di ordine
generale sulla destinazione dei finanziamenti per i servizi sociali e l'assistenza. Nel
1956 l'Olivetti riduce l'orario di lavoro da 48 a 45 ore settimanali, a parità di
salario, in anticipo sui contratti nazionali di lavoro. Si costruiscono quartieri per i
dipendenti, nuove sedi per i servizi sociali, la biblioteca, la mensa. A realizzare queste
opere sono chiamati grandi architetti: Figini, Pollini, Zanuso, Vittoria, Gardella,
Fiocchi, Cosenza, ecc.
Anche nel design industriale Adriano Olivetti sceglie collaboratori di grandissimo
valore, come Marcello Nizzoli e - più tardi - Ettore Sottsass. Tra la fine degli anni '40
e la fine degli '50 la Olivetti porta sul mercato alcuni prodotti destinati a diventare
veri oggetti di culto per la bellezza del design, ma anche per la qualità tecnologica e
l'eccellenza funzionale: tra questi la macchina per scrivere Lexikon 80 (1948), la
macchina per scrivere portatile Lettera 22 (1950), la calcolatrice Divisumma 24 (1956). La
Lettera 22 nel 1959 verrà indicata da una giuria di designer a livello internazionale
come il primo tra i cento migliori prodotti degli ultimi cento anni.
Grande cura viene dedicata anche alla grafica e alla pubblicità e la Olivetti diviene un
punto di riferimento mondiale per il design industriale.
La gamma dei prodotti viene continuamente ampliata e la capacità produttiva si espande
per far fronte a sempre nuove esigenze del mercato nazionale e internazionale. In Italia
entrano in funzione gli stabilimenti di Pozzuoli e di Agliè (1955), di S. Bernardo di
Ivrea (1956), della nuova ICO a Ivrea e di Caluso (1957). In Brasile, nel 1959 si inaugura
il nuovo stabilimento di San Paolo.
Gli ottimi risultati conseguiti sui mercati internazionali con i prodotti per ufficio non
distolgono l'attenzione di Adriano Olivetti dall'emergente tecnologia elettronica. Già
nel 1952 la Olivetti apre a New Canaan, negli USA, un laboratorio di ricerche sui
calcolatori elettronici. Nel 1955 viene costituito il Laboratorio di ricerche elettroniche
a Pisa; nel 1957 Olivetti fonda con Telettra la Società Generale Semiconduttori (SGS) e
nel 1959 introduce sul mercato l'Elea 9003, il primo calcolatore elettronico italiano
sviluppato e prodotto nel laboratorio di Borgolombardo.
Il successo imprenditoriale di Adriano Olivetti ottiene il riconoscimento della National
Management Association di New York che nel 1957 gli assegna un premio per "l'azione
di avanguardia nel campo della direzione aziendale internazionale".
Nel 1959 Adriano Olivetti conclude un accordo per l'acquisizione della Underwood,
l'azienda americana con quasi 11.000 dipendenti a cui il padre Camillo si era ispirato
quando nel 1908 aveva avviato la sua iniziativa imprenditoriale.
Adriano Olivetti muore improvvisamente il 27 febbraio 1960 durante un viaggio in treno
da Milano a Losanna, lasciando un'azienda presente su tutti i maggiori mercati
internazionali, con circa 36.000 dipendenti, di cui oltre la metà all'estero.
 Speciale su Adriano Olivetti (la
Sentinella del Canavese) Speciale su Adriano Olivetti (la
Sentinella del Canavese)
 Biografia
Adriano Olivetti (olivetti.it) Biografia
Adriano Olivetti (olivetti.it)
 Biografia
Olivetti (biol.it) Biografia
Olivetti (biol.it)
 La
singolarità di Adriano Olivetti, di Indro
Montanelli, "Corriere della Sera" 13 giugno 2001 La
singolarità di Adriano Olivetti, di Indro
Montanelli, "Corriere della Sera" 13 giugno 2001
|