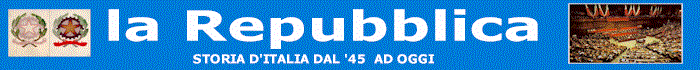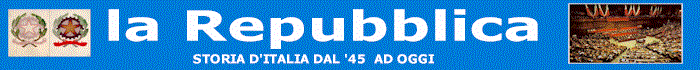Il
Settantasette
 Il '77 e il femminismo Il '77 e il femminismo
a cura di Sébastien Croquet
Il movimento femminista partecipò al movimento del ‘77 e lo
influenzò fortemente, con le sue tematiche e le sue rivendicazioni. Appare utile
descrivere quale fu il suo percorso politico e come si inserirono nel dibattito pubblico
le preoccupazioni di un’intera generazione, che misero in piena luce le debolezze e
l’arretratezza dell’arcaico quadro sociale, " patriarcale "
e cattolico.
In un primo momento analizzeremo gli esordi del movimento femminista,
collocandoli nella stagione dei tumulti sociali. Poi in una seconda parte, vedremo il suo
impegno nel movimento del ‘77, e infine, per concludere, mostreremo quali furono le
conseguenze di dieci anni di lotte, per il femminismo e le sue militanti.
Nel giugno 1971, si tenne a Milano, il primo convegno nazionale dei
gruppi femministi, i cui due gruppi maggiori erano allora il Demau e Rivolta
femminile.Fare iniziare il movimento femminista a partire da quest’evento, non
significa che la questione femminista non fosse mai stata abbordata prima questa data:
" Certo, il movimento operaio e il Partito comunista italiano
avevano superato una concezione secondo la quale la rivoluzione di classe avrebbe portato
a soluzione la "questione femminile". E la "questione femminile" era
già diventata questione nazionale, una di quelle che attraversavano "la via italiana
al socialismo". Ma aggiungere "femminile" al posto di
"meridionale", "giovanile" accanto al termine "questione"
equivaleva a tenere in piedi il concetto di "interesse generale" "
.
Questa volontà di autonomia si tradusse nel separatismo gruppettaro,
per " assolversi dall’egemonia maschilista " e dalla
subalternità alla quale erano ridotte le militanti comuniste o/e della Nuova sinistra,
nelle loro rispettive formazioni politiche.
In realtà, quello che motivò in modo significativo la costituzione di
un vero e proprio movimento femminista, fu la prospettiva di una redifinizione completa di
alcuni concetti. Tra questi la famiglia (soprattutto il rapporto tra l’uomo e
la donna), il corpo (la richiesta di una maggiore emancipazione e il diritto alla
contraccezione), la rimessa in discussione del modo di fare politica…
Dal 1973, nacquero dei gruppi e dei collettivi di medicina, dei centri
per la salute della donna…tutti autogestiti e, elemento importante, aperti a tutte le
donne.
Il loro obbiettivo dichiarato era di sottrarre ai medici e agli
ospedali la gestione della salute e del corpo. Questo perché l’Italia era ancora
molto ancorata alla dottrina cattolica e rimaneva ermetica ai mezzi di contraccezione. La
rivendicazione del diritto di aborto (libero, gratuito e assistito), era infatti una parte
della rivendicazione di base, cioè quella del diritto all’autodeterminazione della
donna, in ogni settore.
Poi, a partire dal 1974, questi gruppi femministi cercarono di imporre
politicamente la legittimità della pratica dell’aborto, praticandolo
clandestinamente. Un numero sempre più importante di donne (nella loro grande
maggioranza, giovani) prese parte a queste pratiche.
Questa stagione di lotte favorì, anzi provocò
l’approvazione, nel luglio del 1975, della legge sui consultori. Le rivendicazioni
delle femministe erano state " istituzionalizzate " e riconosciute,
però inserite in una logica e in una prospettiva riformistica, e addiritura familistica.
Il diritto all’aborto rivelò presto il progetto molto più
complessivo di un vero e proprio riconoscimento della donna come soggetto politico attivo,
ma senza perdere tuttavia le sue specificità femminili.
D’allora in poi si crearono nuovi collettivi politici, nelle
fabbriche, nelle scuole, nei sindacati (soprattutto nella Cgil e nella Csil), nei
quartieri ( che parteciparono attivamente allo sviluppo dei centri sociali), con
l’evidente volontà di fare della diversità femminile, una particolarità
indispensabile della vita politica, e non una debolezza.
È durante quel periodo che si teorizzò e praticò
l’autogestione, che permise inoltre una partecipazione più ampia e un livello
maggiore di democrazia nelle assemblee e nell’organizzazioni politiche.
Furono proprio i temi dell’autogestione e
dell’autoorganizzazione a creare tensioni tra il Mld e il Pci. In effetti il partito
comunista vide nel femminismo il pericolo di un movimento eversivo, difficilmente
integrabile nella sua strategia politica interamente diretta verso il compromesso storico.
Le sue reazioni nei confronti delle femministe lasciarono intravedere un sentimento di
diffidenza, quando non anche di aperta ostilità, almeno fino al dibattito
sull’aborto, in cui le due parti si ritrovarono costrette a conpartecipare alla
lotta.
Le idee e le tematiche femministe ebbero quindi qualche difficoltà per
permeare il dibattito civile e politico, e non solo nella destra tradizionale e cattolica.
Il biennio 1975-1976, segnò un grande ripensamento del concetto del
femminismo, delle sue dottrine, dell’impegno nella lotta (sociale e armata), negli
orientamenti e delle prospettive da darsi, da parte delle femministe.
La loro attenzione si indirizzò molto più verso le relazioni fra
donne, a scapito del loro impegno sul piano sociale.
Il fallimento, alle elezioni del 20 giugno 1976, della sinistra
rivoluzionaria e della Nuova sinistra, insieme all’avanzata del Pci e della sinistra
storica, resero possibile l’operazione riformistica dell’istituzionalizzazione
dei conflitti e delle rivendicazioni. Dopo questa vittoria il movimento per le donne si
sottrasse a questo compito e si orientò piuttosto verso delle questioni e dei problemi di
interesse sociale, di ordine generale, ma mantenendo sempre un legame molto forte con gli
interessi della donna.
Benché le donne patissero la preponderanza maschile e la volontà di
certi militanti (di Lc per esempio) di imporre il loro punto di vista, tutto ciò non
significò l’abbandono delle rivendicazioni e delle tematiche puramente femministe,
nei gruppi della sinistra e nel campo della contestazione e delle lotte sociali.
Le donne rimettevano in questione le grandi linee della politica e i
modi di praticarla, tramite una critica radicale, rivolta all’intera organizzazione,
il che produsse grandi tensioni, fino ad arrivare allo scioglimento di Lotta continua, e
all’uscita delle donne dal gruppo de " Il Manifesto ".
Questo isolazionismo politico fu dovuto essenzialmente a dei punti di vista ideologici
troppo discordanti, tra il movimento femminista e ogni altra formazione politica.
" Nel 1977 il movimento degli studenti parla di bisogni e
vuole dare valore all’individuo nella sua irriducibilità al collettivo e al
progetto. C’è Eugenio Finardi che canta " Il politico è
personale ". Gli indiani metropolitani fanno i girontondi e si dipingono il
viso. " Riprendiamoci la vita " è lo slogan di massa. Sembra
possibile ritrovare le ragioni di una lotta comune. Ma anche lì esplode il conflitto.
Spesso in modo violento ".
Come riassumono Nanni Balestrini e Primo Moroni, la concordanza di
certi temi femministi con le rivendicazioni studentesche e la loro cospicua influenza sul
movimento universitario e creativo che scaturì nel 1977, lasciò presagire l’inizio
di una lotta inedita con nuove tematiche.
In effetti, il terreno sociale (la disoccupazione giovanile) e i nuovi
assetti politici conseguenti alle elezioni svoltesi nel 1976, permisero un’intesa e
un ravvicinamento dei due movimenti.
Entrambi, dalla loro propria realtà sociale soggettiva (precarietà e
disoccupazione), rivendicarono e favorirono una più grande radicalità e autonomia del
movimento nei confronti del sistema politico classico, contro il quale esaltarono
un rifiuto totale di insubordinazione.
La contrapposizione si fece più evidente dal momento in cui il Pci
decise di sostenere apertamente il governo Dc, ciò che rese impossibile ogni mediazione
politica " tradizionale ".
Prima e durante il ‘77 una grande parte delle femministe
praticarono la " doppia militanza ", cioè per lo più, una
partecipazione e un impegno politico attivo nel Pci e nel movimento, il che permise
l’unico esempio di permeabilità tra le due formazioni, che però si deve
relativizzare dato che rimase circoscritto nell’ambiente femminista.
Col movimento studentesco le donne condivisero l’opposizione alla
legge Malfatti, il desiderio di cambiare e rinnovare radicalmente la società, la
politica, il ciclo produttivo, il rifiuto e/o la redifinizione del concetto del lavoro,
l’affermazione di un soggetto sociale e politico sottratto alla centralità delle
organizzazioni partitiche della sinistra, l’autogestione del proprio corpo con la
richiesta di una più grande liberazione sessuale e la depenalizzazione delle droghe…
Con la parte creativa condivisero un’attenzione estrema ai
" nuovi bisogni " attinenti alla sfera della creatività,
dell’affettività e della comunicazione, del complesso rapporto tra l’individuo,
la società e l’arte…
L’opposizione tra i gruppi femministi e quelli maschili che si
inasprì durante il 1977, non fu causato dal movimento di contestazione eponimo, ma
dall’atteggiamento egemonico e isolazionista delle organizzazioni dell’Autonomia
che respinsero e rifiutarono qualsiasi forma di partecipazione delle donne . In effetti la
confiscazione della parola e a volte l’interdizione, per le autonome, di partecipare
ai meeting, alle dimostrazioni, alle tavole rotonde fu una pratica molto diffusa
nell’ambiente autonomo.
Ciò ebbe per effetto di accentuare il divario e il dissenso che
opponeva il Mld, ma anche le altre formazioni femministe, dal resto della sinistra e di
accrescere le discordie interne e l’isolazionismo nel quale si erano da poco
confinate.
Il mondo politico (senza distinzione partitica o ideologica) non
era ancora pronto a cambiare o a modulare la sua organizzazione sociale e gerarchica, e il
rimpensamento tanto atteso avvenne solo dopo il 1977, innanzitutto nel Pci.
Esiste attualmente una linea interpretativa secondo la quale una parte
importante delle donne che scelsero di rimanere nell’autonomia organizzata sarebbe
passata alla lotta armata. Questa tesi può essere accettata solo nella misura in cui una
parte del movimento femminista, fu ricettiva al discorso militarista e rivoluzionario dei
gruppi clandestini e alle loro ideologie. Tuttavia si deve relativizzare
quest’analisi, perchè la percentuale delle donne nelle organizzazioni armate rimase
molto debole.
In realtà la stragrande maggioranza delle donne impegnata
organizzativamente o politicamente non sostenne la deriva armata, e anzi si oppose alla
radicalizzazione della lotta, che fu una delle ragioni del disimpegno massiccio delle
militanti femministe.
Il movimento femminista fu duramente colpito dalla repressione che si
abbatté sul movimento contestatario e sovversivo del 1977 e dal riflusso che segnò la
fine della più grande stagione di lotte sociali e politiche del dopoguerra.
Per alcuni, il movimento del ‘77 simboleggiò l’ultima
occasione per le donne di associarsi con un altro movimento. Per altri la teoria
femminista basata sul ruolo centrale dell’individuo nel meccanismo politico-sociale
avrebbe favorito lo sviluppo di certe tematiche che si ritrovarono negli anni ottanta, che
esaltavano l’individualismo e la preponderenza dell’interesse personale
sull’interesse collettivo.
Sul piano politico la doppia militanza funzionò :
" ..finché il movimento era organizzato in collettivi e gruppi. Allora era
reltivamente facile : da una parte il partito, dall’altra lo stare fra donne. Ma
i collettivi fra il 1978 e il 1979 si sciolgono e quelle donne si trovano nel
loro partito a dover fare i conti, per così dire, senza rete, con la necessità di una
mediazione in loco fra le due militanze. La strada scelta (dagli uomini e dalle
donne) è quella della lotta comune per il rinnovamento della politica. Il Pci
si aprì ai temi dell’individuo, organizzò convegni sui sentimenti ". Le
donne diventarono " ..portatrici di valori salvifici.. ", il che venne
perfettamente riassunto nell’allocuzione di Enrico Berlinguer quando affermò
" che la politica doveva allargare i propri confini e per questo chiede
il contributo delle donne ", che diventarono così " nuovi
soggetti di una vecchia rivoluzione ".
Il movimento del ‘77 fu per vari aspetti un anno perno per il
femminismo, dal suo frastagliarsi " in mille rivoli ", il che non
significò la sua scomparsa, ma piuttosto una redifinizione dei suoi temi e dei veicoli
della lotta.
Come scrisse Pina Sardella nel 1997, si deve concepire il
" dopo ‘77 " come " ..l’inizio di una nuova fase
del movimento (femminista) : frantumatasi l’idea di un progetto totale e
totalizzante, si riparte da quell’identità collettiva, riconosciuta socialmente, che
anni di movimento avevano prodotto. Il senso di questa identità è forte e costituisce il
patrimonio comune, al di là degli ambiti e delle modalità in cui le donne agiranno. Le
scelte di campo si diversificano, secondo gli interessi e le capacità
professionali ".
Il che segnò un nuovo orientamento politico e una visione alla volta
personale e plurale dell’impegno sociale, che rimasero tuttavia condizionati dal
retaggio di due decenni di lotte femministe.
 Percorsi
in rete Percorsi
in rete
 1968-1977: gruppi e
movimenti si raccontano Bibliografie, documenti, immagini, links 1968-1977: gruppi e
movimenti si raccontano Bibliografie, documenti, immagini, links
 La storia di Fausto e Iaio
La storia di Fausto e Iaio
 Il
Movimento del 1977 Il
Movimento del 1977
 Foto del '77 di
Tano D'Amico Foto del '77 di
Tano D'Amico
 Tesi di laurea
sul Movimento del '77 Tesi di laurea
sul Movimento del '77
 La storia di Radio Alice La storia di Radio Alice
 Associazione "Walter Rossi" Associazione "Walter Rossi"
|