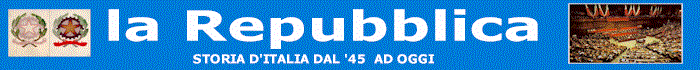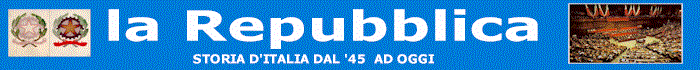Quando l'Italia voleva l'atomica (1956)
Nel grande gioco della Guerra Fredda che poteva diventare caldissima, a
cavallo fra i Cinquanta e i Sessanta, c'è un tassello importante che coinvolge l'Italia.
Non una qualunque Gladio, rossa o bianca che sia. No, è l'ipotesi di un'Italia atomica
sul piano militare, nel senso di un Paese attrezzato con armi nucleari, sia pure a
mezzadria con Francia e Germania. Un progetto che arrivò alle soglie dell'operatività,
sia pur in modo approssimativo e confuso, poi naufragò e le conseguenze sono ancora al
vaglio degli storici. Esempio, peraltro, di quanto fosse frastagliato il mondo bipolare
talora ricordato come assolutamente monolitico. La vicenda emerge dai diari di
Paolo Emilio Taviani - a lungo, in quel periodo, ministro della Difesa - ed è
nota in termini generali dalla metà degli anni Novanta. Ora - in un saggio a firma dello
storico e giornalista Paolo Cacace sul prossimo numero di Nuova Storia Contemporanea -
viene rivisitata e arricchita da documenti e testimonianze dirette fino a ipotizzare
qualche connessione con la lunga ostilità americana nei confronti di Enrico Mattei.
L'idea della «bomba europea» nasce nel '56 da sette incontri segreti - le «riunioni del
caminetto» - fra tre ministri della Difesa: Jacques Chaban-Delmas, Franz Joseph Strauss e
Taviani. Che ha precisato a Nuova Storia Contemporanea : «Si parlava in francese,
senza interpreti e collaboratori». Suez e l'Ungheria danno una spinta. Eisenhower delude
gli europei e, nel novembre '57, i tre arrivano a un protocollo per la standardizzazione
degli armamenti con una parte riservata in cui si parla di «applicazione militare
dell'energia nucleare».
Nell'aprile '58, l'intesa muove un sensibile passo avanti. Si individua l'impianto che
dovrà produrre la «bomba» - a Pierrelatte, in Francia - e si ripartiscono le spese: 45
per cento a Francia e Germania, il resto all'Italia. Taviani è contento, nel diario
annota: «L'incontro di oggi è andato veramente bene, tranne un momento di gelo. Con la
sua durezza, direi poco educata, Strauss ha detto a Chaban-Delmas, senza mezzi termini:
"Gli americani mi hanno detto che i francesi sono folli se pensano di farsi la bomba
da soli...". Ho cercato di aggiustare con una battuta sulla spocchia dell'americano
con il sigaro...». Nella primavera del '58, comunque, l'atomica italo-franco-tedesca pare
in dirittura d'arrivo. Invece fallisce tutto. De Gaulle, appena consolidato il potere col
referendum del settembre '58, punta decisamente sull'atomica solo francese. Poi, giocano
un'altra serie di fattori.
La ricostruzione di Cacace approfondisce le contorte manovre diplomatiche innescate dalla
«bomba» possibile. L'interesse a partecipare degli inglesi che però è forse soltanto
un diversivo ispirato da Washington. L'ambiguità dei protagonisti che giocano tutti su
più tavoli, a partire dal rapporto con gli Usa apparentemente quasi sfidati. Del resto,
lo stesso Taviani - per esempio nella vicenda Gladio - è considerato amico solidissimo
degli americani. E poi per una fragilità intrinseca del progetto. Cacace cita Taviani:
«Il punto debole di questi accordi era che si trattava degli aspetti tecnico-economici
senza aver chiarito la struttura politica portante... Poi non fu deciso chi avrebbe tenuto
in mano le chiavi della futura arma nucleare. La Francia per tutti e tre? Sarebbe stato
inaccettabile. Sarebbe stato necessario individuare preliminarmente un'istituzione in
grado di decidere in un campo così delicato». L'atomica europea svanisce. Ma forse non
senza lasciare tracce. La più interessante, per noi, riguarda il ruolo di Mattei,
presidente dell'Eni potentissimo e influente nella politica estera italiana dell'epoca.
Taviani ha escluso che Mattei avesse contribuito a orientare le trattative.
«Non va trascurato, tuttavia - scrive Cacace - che in quel periodo proprio Mattei era,
insieme a Giovanni Gronchi, il principale artefice di una politica estera parallela che
incontrava forti ostilità presso gli ambienti politici ed economici statunitensi. Mancano
le prove, è vero, di un suo coinvolgimento diretto nel "dossier nucleare". Ma
è difficile credere che Mattei fosse all'oscuro di tutto anche perché proprio in quel
periodo i rapporti tra l'Eni e l'amministrazione Eisenhower toccavano il punto più
critico...».
Un rapporto dell'Operations Coordinating Board del 3 settembre 1957 intitolato «La
minaccia di Mattei agli obiettivi degli Stati Uniti» nota il pericolo che Mattei «usi i
suoi privilegi e la sua influenza per frustrare l'espansione dell'impresa privata in
Italia attraverso l'espansione nel settore chimico e nucleare». «Insomma - sottolinea
Cacace - non si può escludere che la cautela americana verso Mattei fosse connessa in
qualche modo alla partita che contemporaneamente si svolgeva sul terreno delle iniziative
nucleari».
(Corriere della Sera, 4 aprile 2002)