|
I Giusti italiani
Nonantola, Villa Emma
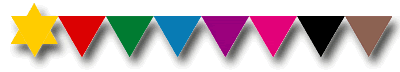

I 40 bambini ebrei, che
arrivarono il 17 giugno 1942 a Nonantola, erano in realtà diretti in Palestina, quando
l'occupazione tedesca e italiana della Jugoslavia gli bloccò la strada nel 1941. Durante
il viaggio per arrivare in Italia sostarono per un certo periodo nella parte del
territorio sloveno annesso dall'Italia, prima di arrivare a Nonantola. Nell'aprile del
1943 vi si aggiunse un secondo gruppo di 33 bambini, che arrivavano da Spalato. Erano
tutti orfani che avevano perso i genitori nei campi di concentramento e che erano stati
portati oltre la frontiera tedesca dalla nota sionista Recha Freier con l'aiuto di alcuni
contrabbandieri.
Nella Villa Emma i bambini e ragazzi, dell'età dai sei ai vent'anni, vivevono insieme ai
loro accompagnatori e ai loro educatori, Josef Indig, Marco Schoky e il pianista Boris
Jochverdson, in condizioni modeste, ma tutto sommato buone, cosicché poterono riprendere
le lezioni ed essere istruiti al lavoro agricolo e a lavori artigiani per prepararsi
all'immigrazione in Palestina e alla futura vita in un Kibbuz. La popolazione di Nonantola
ebbe una grande simpatia per questi giovani rifuggiati, perché sapevano che avevano perso
i genitori, e nonostante il divieto di uscire da soli e il controllo attento della
Questura nacquero amicizie tra i giovani ebrei e gli abitanti di Nonantola.
Con l'occupazione tedesca dell'Italia dopo l'armistizio con gli Alleati l'8 settembre 1943
e l'arrivo delle truppe tedesche a Nonantola, la situazione cambiò radicalmente. In meno
di 48 ore Villa Emma fu abbandonato e le ragazze e i ragazzi trovarono rifugio presso il
seminario dell'Abbazia e nelle case dei contadini, degli artigiani e negozianti dei
dintorni. Un grande coraggio in questa situazione fu dimostrato da Don Arrigo Beccari.
Visto che tutti avevano molta paura della razzia della polizia tedesca, venne organizzata
la fuga attraverso la frontiera con la Svizzera, che avvenne tra il 28 settembre al 16
ottobre 1943.
Nell'oscurità i bambini guadarono il fiume Tresa. In Svizzera le associazioni sioniste li
alloggiarono in un istituto a Bex nella valle del Rodano, da dove la maggiorparte di loro,
dopo una fuga durata 5 anni, arrivò in Palestina nel maggio del 1945. Uno dei ragazzi,
che si ammalò di tuberculosi e che fu ricoverato in un sanatorio, non riuscì a fuggire.
Il suo nome si ritrova nell'elenco di un convoglio per Auschwitz.
Don Arrigo Beccari e il medico Giuseppe Moreali sono stati in seguito onorati nello Yad
Vashem per l'aiuto coraggioso e generoso da loro prestato, ed è stato loro dedicato un
albero nel Viale dei Giusti.
*** ***
Il paese degli Uomini
Giusti nascose ai nazisti 73 giovani ebrei
di Jenner Meletti
Lascia un
attimo la corona del rosario e dice: "Pregherò più tardi, il tempo non mi manca,
adesso". Una faccia larga e buona, gli occhi vivissimi. "I ragazzi ebrei? Certo
che li ricordo. Erano piccoli, e tanti erano orfani. Non facciamo tante storie, aiutarli
era un obbligo. Tutto qui".
Don Arrigo Beccari, 92 anni, dalla sua stanza nell'ex seminario guarda i tetti della
cittadina. "E' vero. A Gerusalemme, nel 1965, su due alberi del viale degli Uomini
Giusti hanno messo il mio nome e quello di Giuseppe Moreali, medico condotto. Mamma mia,
avere un titolo grosso come "Uomo Giusto" è una bella responsabilità. Speriamo
di meritarlo".
La storia del vecchio prete e del dottore è dentro la cartella che il professor Klaus
Voigt, storico tedesco, ha portato ieri da Berlino, per consegnarla all'archivio del
Comune. "Quasi vent'anni di ricerche, ma ora ho finito. Il libro uscirà fra due mesi
in Germania, poi sarà tradotto e pubblicato anche in Italia. "Villa Emma: ragazzi
ebrei in fuga. 1940-1945". Credo che in nessuna altra parte d'Europa sia avvenuta una
cosa come questa: 73 ragazzi ebrei, e 18 accompagnatori, salvati da un intero paese. E la
cosa più bella è che nessuno qui si è mai vantato di nulla. Erano ragazzi, dicono, poco
più che bambini, e rischiavano di finire in campo di sterminio. Si poteva forse fare
finta di nulla?".
Otto settembre del 1943. Agli usci delle case, in paese e in campagna, bussano ragazze e
ragazzi. Dicono: "Sono di Villa Emma", e sembra una parola d'ordine. Le porte si
aprono, si preparano i letti e si mette un piatto in più. Stanno arrivando i tedeschi, i
ragazzi vanno nascosti. Tutti sanno, da quasi un anno, chi siano "quelli di Villa
Emma". Anche i fascisti, che fanno finta di nulla. Sono ebrei in fuga già
dall'ottobre del 1940.
Erano partiti da Berlino e da altre città tedesche, volevano arrivare in Palestina
attraversando la Jugoslavia e la Turchia, assistiti dalla Delasem, l'organizzazione ebrea
per l'assistenza agli emigranti. Si fermano a Zagabria, ospiti di famiglie ebree, che
assicurano che "qui non ci saranno mai le cose brutte che avvengono in Germania e
Austria". Ma il 10 aprile 1941 arrivano i nazisti, e i ragazzi ebrei debbono tornare
verso il Nord. Per più di un anno si fermano nel castello di Lesno Brdo, in Slovenia
meridionale, annessa dall'Italia. Si mangia polenta condita con i cardi trovati nei campi,
e si organizza una scuola con tre classi, perché i ragazzi non possono perdere anni
preziosi. Ma il castello è al centro degli scontri fra partigiani di Tito e soldati
italiani, bisogna partire.
I ragazzi arrivano a Villa Emma il 17 luglio 1942. "E' l'unica autorizzazione
all'ingresso di ebrei in Italia - dice il professore Klaus Voigt - rilasciata dal
ministero durante la guerra".
Manca tutto, a Villa Emma, abbandonata da vent'anni. Don Arrigo Beccari, parroco e
insegnante di lettere, porta le brandine del seminario. Il medico Giuseppe Moreali cura i
ragazzi. Anche qui organizza la scuola. Una stanza diventa sinagoga, con i rotoli della
Torah. Arrivano gli aiuti delle comunità israelitiche. Una vita quasi normale: si può
fare il bagno nel Panaro, quando il sole picchia sulla pianura. I ragazzi lavorano anche
in campagna, con il mezzadro Ernesto Leonardi. In cambio hanno le patate per l'inverno, e
imparano il mestiere del contadino, nella speranza di arrivare nei kibbuz.
Otto settembre. Arrivano i tedeschi, ed i capi della comunità di Villa Emma sanno già
cosa succederà. I più piccoli piangono ogni sera, perché hanno ricevuto una cartolina
del padre o della madre che dice soltanto: "Sono partito". Non possono scrivere
altro, per annunciare il viaggio verso il campo di sterminio.
In una notte Villa Emma si svuota. Trenta ragazzi e ragazze nel seminario, gli altri nelle
case. "Ho tre figlie, tu sarai la quarta". "C'è posto nella stalla, con i
miei figli". I tedeschi arrivano il 9 settembre. Forse anche loro sanno, ma non fanno
rastrellamenti. Hanno paura della rivolta di un intero paese. Ma non si può resistere a
lungo. Tutti su un treno, alla stazione di Nonantola, nel pomeriggio del 6 ottobre 1943. I
documenti - preparati da un impiegato comunale che ha rubato le carte di identità in
municipio - dicono che questi ragazzi sono collegiali, diretti verso Ponte Stresa.
"Per arrivare in Svizzera - dice il professor Klaus Voigt - i ragazzi e i loro
accompagnatori dovettero guadare al buio il fiume Tresa. Venne formata una catena, in cui
i più grandi e più forti si alternavano con i più piccoli, perchè la corrente non li
portasse via". Tutti salvi, meno un ragazzo malato ricoverato in un sanatorio a
Pavullo, e portato ad Auschwitz.
Tutti salvi, meno Goffredo Pacifici, bidello di Villa Emma, arrestato e deportato una
settimana dopo mentre portava in Svizzera altri ebrei.

I ragazzi di allora sono tornati nel 1996 per abbracciare chi li aveva
aiutati. L'anno scorso, in Municipio, è arrivata una lettera. "Abbiamo piantato
cento alberi in onore dei cittadini di Nonantola. Sono la memoria del bene. I ragazzi di
Villa Emma, con affetto eterno".
(la repubblica, 20 gennaio 2001)
 Comune di
Nonantola Comune di
Nonantola
 Giuseppe
Moreali e don Arrigo Beccari Giuseppe
Moreali e don Arrigo Beccari
 Villa
Emma, isola di speranza (Shalom, n. 11, 2001) Villa
Emma, isola di speranza (Shalom, n. 11, 2001)
|