home |
|
Biografia
 Bruno Zevi Bruno Zevi
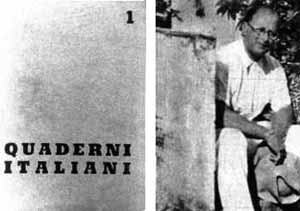
Storico e critico dell'architettura, docente universitario. Nato a Roma il 22 gennaio del 1918 in una delle più antiche famiglie
ebree della capitale, da Guido e Ada Bondi. L'ingegnere Guido Zevi entrò
nell'amministrazione capitolina al tempo del grande sindaco Nathan fino al grado di
ingegnere-capo. Ebbe nel 1920 e 1921 due medaglie d'oro dalla Giunta Municipale per la sua
dedizione e la sua competenza. Con l'avvento del fascismo e di fronte ai sintomi della
corruzione si dimise. La persecuzione degli ebrei negli anni Trenta rafforzò la sua
adesione al sionismo e lo portò alla vice-presidenza dell'Unione delle Comunità
Israelitiche Italiane. Nel 1940 i genitori di Bruno raggiunsero le due figlie Adriana Zevi
Milano e Marcella Zevi Sonnino trasferitesi nella Palestina ebraica. L'ingegnere Guido
riprese da zero la nuova vita a Ramatayim, sobborgo di Tel Aviv. Lì morì nel 1975 e lì
riposa insieme alla moglie Ada, scomparsa nel 1946.
Bruno Zevi ha cospirato contro il fascismo già negli anni del
Liceo Tasso, compagno di banco di Mario Alicata, amico di Paolo Alatri e Carlo Cassola. Il
2 ottobre del 1935, il giorno in cui il duce annunciò la guerra contro l'Etiopia, Zevi
era a piazza Venezia, proprio insieme a Cassola e Alicata. Dirà molti anni dopo che
proprio quel discorso, così carico di retorica e di nazionalismo, fu la molla che fece
scattare il suo antifascismo. Parte dei giovani che in quegli anni parteciparono, come
dissenzienti, alle manifestazioni culturali del fascismo confluiranno nel Partito
comunista (Alicata, Alatri, Cassola, Aldo Natoli, Ruggero Zangrandi, Paolo Bufalini).
Altri, come Zevi, seguace di Carlo Rosselli, approderanno invece alle rive
liberalsocialiste, in uno dei rami del movimento "Giustizia e libertà".
Durante la guerra di Spagna, alla quale partecipava la colonna
italiana promossa da Carlo Rosselli, aiutò a raccogliere fondi per il fronte democratico
e maturò profondamente il suo anticomunismo alla notizia dell'assassinio dell'anarchico
Berneri a Barcellona nel maggio 1937 da parte dei comunisti. Per le leggi razziali del '38
fu esonerato dal servizio militare che stava compiendo come allievo ufficiale del Genio.
Dato il clima antiebraico, si trasferì a Londra nel 1939, dove frequentò il terzo anno
di Architettura, dopo il biennio a Roma, e portò avanti l'attività politica antifascista
con Carlo Ludovico Ragghianti. Nel gennaio del 1940 a Parigi conobbe i dirigenti del
movimento Giustizia e Libertà Emilio Lussu, Alberto Cianca, Aldo Garosci, e, da poco
arrivato, Tullio Ascarelli. Il mese dopo si trasferì a New York per continuare gli studi
universitari e portare avanti la lotta antifascista con Lionello Venturi, Veniero
Spinelli, Franco Modigliani, Aldo Garosci, Gaetano Salvemini. Quello stesso anno, Zevi
tornò in Italia sotto falso nome per ristabilire i contatti con i compagni di Giustizia e
libertà. Tornato a New York, in dicembre sposò Tullia Calabi, milanese, ebrea, che
condivideva e condividerà sempre il suo impegno antifascista, la fede giellista ed
azionista. Membro attivo della "Mazzini Society", diresse i "Quaderni
italiani", considerati la continuazione di quelli parigini di Carlo Rosselli, e
intanto nel '41 si laureò in architettura a Harvard con Walter Gropius, scoprendo con
Wright il valore della libertà dell'architettura. Con la ripresa dei Quaderni fu
ricostituito il movimento Giustizia e Libertà negli Stati Uniti. Uscirono quattro
fascicoli dal gennaio 1942 al 1944, quando i principali redattori erano già rientrati in
Europa. Il terzo era dedicato tutto alla partecipazione antifascista alla guerra di
Spagna. La redazione era presso l'abitazione di Bruno Zevi a Boston. Proseguiva l'azione
politica volta a dimostrare all'opinione pubblica americana che Italia e fascismo erano
termini antitetici: si utilizzarono trasmissioni radio a Boston nel 1942 e la NBC di New
York nel 1943. Il 30 giugno 1943 Alberto Cianca, Aldo Garosci, Alberto Tarchiani e Bruno
Zevi si imbarcarono per l'Europa sulla nave "Queen Mary" spogliata del suo
arredo per trasportare 15 mila soldati e il loro armamento, esposti a possibili attacchi
di sottomarini tedeschi, perché senza adeguata scorta. Giunti in Inghilterra si attivò
la radio clandestina Giustizia e Libertà, che trasmetteva giorno e notte attaccando il
regime e la monarchia e affiancando i primi nuclei partigiani. Dal Messico arrivarono Leo
Valiani e Bruno Pierleoni.
Tutti i compagni partirono per l'Italia, dopo lo sbarco degli Alleati nella penisola e per
la radio clandestina restò solo Zevi: "Malgrado le proteste, la scelta cadde su di
me: avevo un timbro di voce così acuto da superare il sibilo che i fascisti
sovrapponevano alle nostre trasmissioni". Dopo qualche settimana il generale
Eisenhower dette ordine di sopprimere radio Giustizia e Libertà, perché "dannosa
agli obiettivi degli alleati", che andavano verso un compromesso con la monarchia.
Non potendo muoversi dall'Inghilterra, perché impedito, Zevi fu capo-progettista dei
campi militari per l'invasione della Normandia. Divenne amico di Arthur Koestler, Renato e
Piero Treves, Ruggero Orlando e degli esponenti della sinistra laburista del movimento
"Common Wealth" di tendenza liberalsocialista.
Il 31 luglio 1944 rientrò a Roma e si iscrisse subito al Partito d'Azione, che diverrà
il suo unico vero partito.
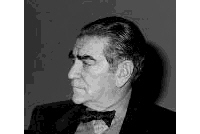
Restò nel partito dopo la scissione del 1946, malgrado la stima
per Parri, La Malfa, Ragghianti; partecipò alle elezioni romane nella lista "Blocco
del Popolo"; non votò per lo scioglimento del Partito d'Azione nel 1947 e per la
confluenza nel PSI. Dopo aver assistito al crollo del Partito d'Azione, continuò a essere
un animatore della politica italiana. Convinto anticomunista e altrettanto convinto
antidemocristiano, Zevi è stato, sempre, al fianco della sinistra. Di una sinistra che
avrebbe voluto più combattiva, più aspra, più decisa nella difesa dei valori del
socialismo democratico.
Nei primi anni della Ricostruzione italiana il suo contributo fu travolgente. Fondò
l'Apao (Associazione per l'architettura organica) cenacolo di lotte e dibattiti, di
speranze politiche e architettoniche che si erano travasate nella ricostruzione italiana.
Capeggiò l'azione dei giovani architetti romani per fermare la costruzione "archi e
colonne" della testata della Stazione Termini; contemporaneamente con Mario Ridolfi e
Pier Luigi Nervi partecipò alla stesura del Manuale dell'Architetto, indispensabile
strumento di aggiornamento professionale per i progettisti italiani. Co-diresse
"Metron", che vedrà importanti scritti dei più anziani Luigi Piccinato e
Giuseppe Samonà, nel 1955 fonda "L'architettura" e tenne una rubrica su
"L'Espresso" da cui affiancava settimanalmente le battaglie architettoniche e
urbanistiche che conduceva anche attraverso l'InArch (Istituto nazionale di architettura)
e l'Inu (Istituto nazionale di urbanistica) di Adriano Olivetti. Collaborò anche con
alcuni governi dell'epoca: fu alla Direzione dell'Ufficio urbanistico del
sottosegretariato alle Belle Arti durante il governo Parri nel 1945, membro del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, sezione Urbanistica, membro della Commissione nazionale per
la Programmazione Economica nel 1963, con Ugo La Malfa al Bilancio e Fiorentino Sullo (uno
dei pochi democristiani stimati da Zevi) ai Lavori Pubblici.
Col movimento di "Unità popolare" partecipò nel '53
alla lotta contro la "legge truffa" e tentò di far rivivere gli ideali dispersi
del Partito d'Azione con la costruzione di un terzo polo della sinistra, né comunista né
clericale.
Membro del Comitato centrale del Partito Socialista Unificato nel
1966, è stato sempre vicino all'azione di Danilo Dolci in Sicilia, al Centro Studi e
Iniziative di Trappeto, partecipando alla marcia contro la mafia nel 1967 nella Sicilia
Occidentale. A Zevi fu affidata la commemorazione di Paolo Rossi studente-architetto,
membro della Federazione Giovanile Socialista, morto il 27 aprile 1966, in seguito agli
scontri coi neofascisti, avvenuti nella città universitaria.
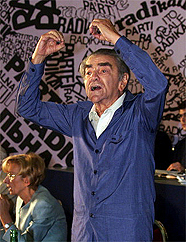
Ha retto per 30 anni la cattedra di Storia dell'architettura nelle università di
Venezia e La Sapienza di Roma. E' stato segretario generale dell'Istituto Nazionale di
Urbanistica dal 1952 al 1968 e vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Architettura
dalla sua fondazione, nel 1959. La grande ondata studentesca del
1968 lo vedrà appassionatamente accanto ai suoi allievi, al punto da essere incriminato
per apologia di reato. Altrettanto passionale, poco dopo, la sua scomunica degli eccessi
del movimento studentesco. Clamorose le sue dimissioni per protesta contro una università
che egli giudicava "di massa e classista".
Ha fondato nel 1976 Teleroma 56, la prima stazione televisiva indipendente che trasmetteva
a Roma.
Riavvicinatosi ai socialisti, che con Craxi e Martelli dichiaravano di richiamarsi a
Rosselli e al liberalsocialismo, nel 1983 si presentò candidato del Partito
Socialista Italiano alle elezioni nazionali.
Successivamente, entrò nel partito radicale, condividendone le battaglie libertarie. Nel
1987 fu eletto deputato per il Partito Radicale nella circoscrizione Venezia-Treviso.
Nel 1988 fu eletto presidente del Partito Radicale.
Nel 1991 si è dimesso da presidente del Partito Radicale e fu nominato presidente
d'onore.
Non condividendo le scelte della Lista Pannella e della
Lista Bonino, e l'alleanza con la destra, ha appoggiato il centrosinistra, sostenendo
attivamente nel '97 la candidatura di Rutelli al Campidoglio. Il 28 dicembre 1998 fondò a
Roma il Partito d'Azione Liberalsocialista, con simbolo e programma nuovi, con Aldo
Rosselli e Giorgio Parri.
L'ultima battaglia Bruno Zevi l'ha condotta come presidente del Partito radicale quando
Marco Pannella e Emma Bonino hanno cercato di far passare l'accordo col razzista Le
Pen per costituire un gruppo parlamentare comune a Strasburgo. E' morto a Roma il 9
gennaio del 2000.
L'opera
Architetto, storico e teorico dell'architettura, ha privilegiato
l'attività storico-critica rispetto a quella di progettista. Divulgatore dell'opera
dell'architetto americano Frank Lloyd Wright e dell'architettura organica ha scritto molte
opere. E' stato segretario generale dell' Istituto Nazionale di Urbanistica (con Adriano
Olivetti presidente) dal 1952 al 1968 e vicepresidente dell' Istituto Nazionale di
Architettura dalla sua fondazione, nel 1959. Accademico di San Luca e laurea honoris causa
di varie università (tra le quali Buenos Aires, Haifa, Michigan) ha presieduto il
Comitato Internazionale Critici di Architettura (Cica). Ha diretto la rivista "L'
architettura - cronache e storia", fondata nel 1955, e per decenni ha curato la
rubrica di architettura del settimanale L' Espresso. E' stato anche responsabile della
collana "Universale di architettura". Nelle opere urbanistiche e di edilizia
progettate con il suo contributo figurano, tra le altre, la stazione ferroviaria di Napoli
(1955-65); il quartiere Pastena di Salerno (1960); il progetto per il ponte Garibaldi a
Roma (1960); la biblioteca "Luigi Einaudì di Dogliani (Cuneo); gli studi per l' asse
attrezzato e i nuovi centri direzionali di Roma (1975); il piano regolatore di Benevento
(1985-90); la sistemazione delle aree ferroviarie di Firenze. Ha progettato anche il
padiglione italiano per l' Expo di Montreal del 1967. Tra le sue numerose pubblicazioni,
tradotte in oltre venti lingue, vanno ricordate: Saper vedere l'architettura del
1948, arrivata nel 1977 alla ventesima edizione; Architettura in nuce del 1960; Erich
Mendelsohn: opera completa del 1964; Storia dell'architettura moderna del 1950;
Pretesti di critica architettonica del 1983; Zevi su Zevi del 1993;
Leggere, scrivere, parlare architettura del 1996; Storia e Controstoria
dell'architettura in Italia.
(notizie tratte dalle biografie di Gianni Corbi, Nicola Terracciano
e Antonino Saggio) |